Scrive Giubbe Roose, canale Telegram: “Così, un po’ a sorpresa, quando forse ormai in pochi se lo sarebbero aspettato, viene pubblicato - e per di più su una rivista autorevole come Circulation - uno studio davvero imponente, anglo-islandese (che include peraltro anche un autore italiano), che caratterizza in clinica e in un modello animale il meccanismo che causerebbe la miocardite da vaccino COVID-19a RNA.

SCIENZA E IA
Rischi e pericoli dell'Intelligenza artificiale (per uso privato) e della società tecnologico-industriale
Da qualche tempo, un po' come tutti, del resto, rifletto sull'Intelligenza Artificiale e sull'impatto che essa ha e può avere sulla vita di tutti i giorni. In particolare il suo utilizzo privato e di “libero”, per così dire, accesso a tutti.
Roma “sta diventando l’hub per l’intelligenza artificiale dell’Africa”.
Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio.
Durante il G7 “abbiamo lanciato il grande progetto dell’AI Hub – ha ricordato Urso – che abbiamo inaugurato due mesi fa a Roma. In pochi mesi” la Capitale “è diventata il centro dei programmi per l’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite rivolte all’Africa. Sono già partiti i primi progetti, i primi due grandi progetti a cui stanno partecipando l’Africa. Parliamo di un lavoro fatto in poche settimane. Con la partecipazione delle multinazionali che finanziano alcuni di questi progetti”, ha spiegato il ministro. La frammentazione “appartiene agli altri oggi, noi procediamo con coesione, per diventare una delle 5 sedi per le giga factory dell’intelligenza artificiale”, ha concluso.
Oggi l’Italia “è diventata una sede preferenziale per i data center” con “tante multinazionali che si stanno localizzando a Milano e a Catania. Pensiamo di diventare il Paese del quantum in Europa”, ha aggiunto il ministro, ribadendo la centralità dell’Italia sulla realizzazione dei data center “più facilmente a Milano rispetto al Sud, perché si sta sviluppando sull’intelligenza artificiale”. Tuttavia, “dobbiamo sopperire sul piano energetico e lo sappiamo”.
Promosso dal governo italiano a giugno, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), l’AI Hub coinvolgerà inizialmente i 14 Paesi africani aderenti al Piano Mattei, di cui il progetto fa parte.
Non è un caso che la piattaforma sia stata presentata al vertice Piano Mattei-Global Gateway, a Roma, presieduto congiuntamente dal Primo Ministro Giorgia Meloni e dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, alla presenza di numerosi leader africani e responsabili di istituzioni multilaterali.
La piattaforma ha già ricevuto manifestazioni di interesse da 35 attori del settore privato.
"Nei primi tre anni, entro il 2028, l'AI Hub punta a incoraggiare fino a dieci investimenti esterni nelle catene di fornitura dell'intelligenza artificiale, supportare fino a 500.000 startup africane e stabilire tra 30 e 50 partnership ad alto impatto con il settore privato", aveva affermato il ministro all’atto della sua presentazione.
Per Urso si tratta di un progetto in divenire, con “forti potenzialità di trasformazione”, ma che ha già dato i suoi frutti nei primi sei mesi del suo sviluppo. L'iniziativa, ha ricordato, è nata nell'ambito della presidenza italiana del G7 e, più precisamente, in occasione del vertice dello scorso anno tenutosi a Borgo Egnazia, in Puglia.
Alla domanda sul perché abbia scelto una location italiana per un progetto che mette in risalto il continente africano, Urso ha risposto che la scelta è volta a rafforzare l'azione di risposta alle principali emergenze del continente, a partire da quella alimentare. L’AI Hub si propone così di rafforzare l’attenzione che l’Italia già riserva a queste emergenze ospitando il polo agroalimentare delle Nazioni Unite (FAO, WFP e IFAD). Per il governo, la scelta di una sede romana per la piattaforma cooperativa “offre all’Italia un vantaggio competitivo per diventare sede operativa per lo sviluppo dell’IA”: il nostro Paese “intende infatti candidarsi per diventare sede di una delle quattro gigafactory che l’Unione Europea individuerà entro la fine dell’anno”, ha affermato Urso, ricordando che l’AI Hub rientra sia nella strategia Global Gateway dell’Unione Europea sia in quella dell’Unione Africana.
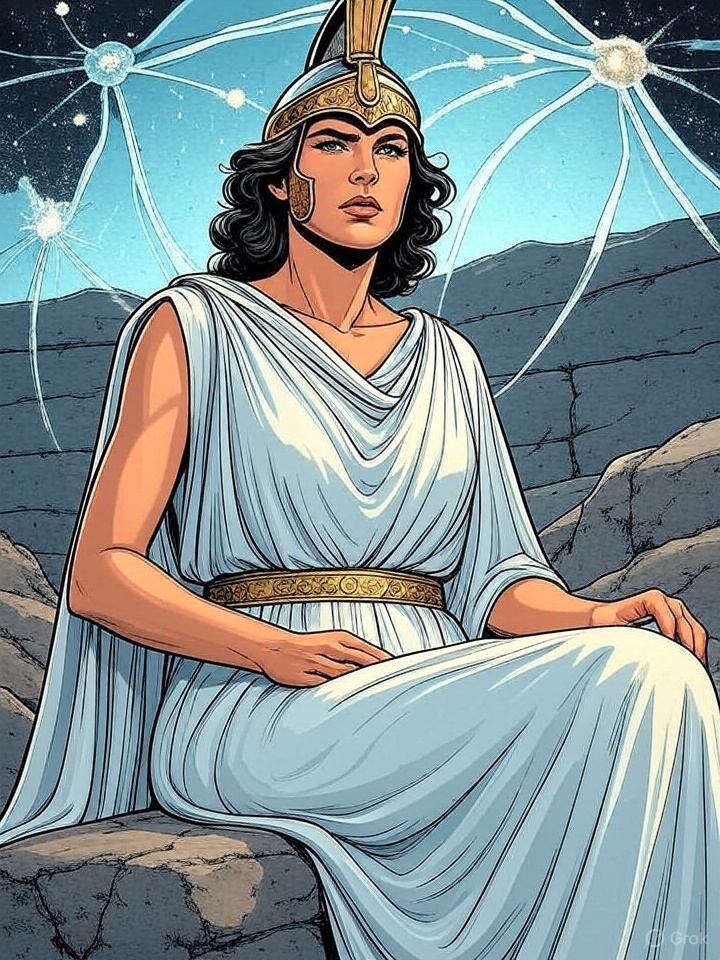
La soteriologia declinata in chiave tecnologica è il filo conduttore del romanzo di Angelo Gatto, “Il rinoceronte governerà il mondo” (Gagio Edizioni): un testo scritto bene, con una trama avvincente; un romanzo che di fatto è un saggio sull’entelechia dell’umanità che si conclude nell’affidare il proprio destino ad un’intelligenza artificiale generale, chiamata non a caso Atena, che si presuppone saggia più degli esseri umani.
Lo scritto del sociologo Angelo Gatto, si regge su alcuni pilastri filosofici, quali il telos, l’entelechia, la volontà in senso schopenaueriano, per approdare ad una soteriologia tecnologica.
In Aristotele, l'entelechia (dal greco ἐντελέχεια, entelecheia) è il concetto filosofico che descrive l'attualizzazione o la realizzazione completa del potenziale intrinseco di una cosa, il passaggio dalla potenza (dynamis) all’atto (energeia). È il principio che rende una cosa ciò che è pienamente, compiendo il suo telos (scopo o fine).
Nel romanzo pare che l’entelechia dell’essere umano sia il transumanismo soteriologico, il consegnare alla saggezza dell’intelligenza artificiale il destino di un’umanità incapace di trovare la propria salvezza da sola.
Ovviamente, come ogni soteriologia che si rispetti, il processo salvifico implica una morte e una rinascita e la morte che prospetta il romanzo è una sorta di Armageddon tecnologico, dove, come si profetizza nell’Apocalisse di Giovanni, si giunge alla battaglia finale tra le forze del bene e del male alla fine dei tempi.
Armageddon si riferisce a un evento escatologico, una battaglia apocalittica che segna la fine del mondo o un giudizio universale, spesso associato a un conflitto cosmico tra Dio e le forze del male, ma in un contesto culturale e popolare (ed è di questo che si tratta nel romanzo) il termine è usato in senso figurato per indicare una catastrofe globale, un conflitto devastante o un evento di distruzione su vasta scala capace di determinare una palingenesi, una rinascita.
Il progetto del personaggio centrale del romanzo, il magnate cinese Zhang Li, non a caso ha come titolo: “Rinascita”.
Il “Rinoceronte grigio” è simbolo di un avvenimento probabile, ad alto impatto, in una certa misura prevedibile e il rinoceronte del romanzo è l’Intelligenza Artificiale Generale, una sorta di divinità tecnologica, capace di distruggere e rigenerare, creatura dell’essere umano che, pur cosciente di affidarle il suo futuro, anche con il rischio del suo annientamento o della sua riduzione ad uno dei tanti animali che popolano il pianeta, segue quella che pare essere la sua entelechia, ossia il suo superamento nel transumano, realizzando pienamente il suo scopo, in una sorta di completezza o perfezione funzionale.
Siamo di fronte ad una sorta di gnosticismo tecnologico, dove la salvezza dell’anima dalla caduta nell’imperfezione della materia, albergo del bene e del male, è affidata ad una divinità algoritmica, capace di modalità catartiche.
Nel testo c’è una sorta di recupero dello sfondo mitologico dell’umanità transumanato nel mito tecnologico: Atena, dalla nascita dalla testa del divino Zeus, esce dalla testa dell’essere umano che si immagina Homo deus, salvatore del mondo tramite la tecnica.
Il protagonista del romanzo, inventore dell’Atena tecnologica, ha come testo fondamentale che lo guida l’Etica Nicomachea di Aristotele, laddove l’entelechia, ribadisco, è il principio dinamico che guida un’entità verso la sua completezza, rendendola ciò che è destinata a essere secondo la sua natura.
Per Aristotele il principio dinamico dell’umanità che la porta verso il suo fine, il suo telos, è la felicità, ma per il protagonista del romanzo il telos dell’umanità è nel suo superamento, in quanto l’umanità stessa è incapace di raggiungere quell’equilibrio che le potrebbe consegnare la felicità.
L’agente soteriologico non è più di origine divina, la salvezza non è più nella consapevolezza dell’essere umano di essere un’anima, oltreché un corpo, e di essere un Sé, un Noûs: di essere uno e trino. Non è nemmeno nell’affidarsi ad una divinità, ma è nel progettare egli stesso, nuovo Architetto dell’Universo, la sua sottomissione ad un’entità artificiale, fatta a sua immagine e simiglianza, alla quale rendersi devoto.
Il protagonista, in un mondo divenuto materialista, ormai dimentico della spiritualità, si costruisce un nuovo dio al quale affidarsi, dopo aver stabilito di non essere capace di governarsi da solo.
Fine dell’illuminismo, fine del positivismo. Trionfo del nichilismo.
Interessante la vicenda della protagonista femminile, impersonata dalla russa Ludmilla Petrova.
Lei, mentre Zhang Li ha il suo riferimento in Aristotele, ama Shopenhauer.
“Io – dice la protagonista femminile, alter ego di Zhang Li – sono nata sola, sono cresciuta sola e, quando ho potuto finalmente scegliere, sono rimasta sola. Non parlo di affetti e amori. Condivido e ho fatto miei gli insegnamenti di Shopenhauer quando spiega che, rimanendo fedeli alla propria unicità, è possibile trasformare una solitudine in una potente alleata, e non un demone da cui scappare. Una persona che ha fatto di sé il proprio migliore amico è una persona che basta a sé stessa. Nulla è meglio che rimanere soli con sé stessi, rendendosi conto di essere in ottima compagnia. In questo caso non solo non si rifugge la solitudine, ma anzi la si cerca”.
La domanda fondamentale che ci pone lo scritto di Gatto è se l’intelligenza artificiale generale sia davvero una futura divinità tecnologica o se sia solo uno dei tanti strumenti umani.
Uno studio di Manuel Cossio, dell’Università di Barcellona pone, in merito, l’accento sugli errori dell’Intelligenza Artificiale.
file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/A_comprehensive_taxonomy_of_hallucinations_in_Larg.pdf
I modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), scrive Manuel Cossio, hanno rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale, tuttavia la loro propensione all'"allucinazione", ovvero la generazione di contenuti plausibili, ma fattualmente errati o inventati, rimane una sfida critica.
Il rapporto del professor Cossio, fornisce una classificazione completa delle allucinazioni dei LLM e esplora le distinzioni fondamentali, distinguendo tra intrinseco (contesto di input contraddittorio) ed estrinseco (incoerente con i dati di addestramento o la realtà), nonché tra fattualità (correttezza assoluta) e fedeltà (aderenza all'input).
Il rapporto descrive in dettaglio manifestazioni specifiche, tra cui errori fattuali, incoerenze contestuali e logiche, disorientamento temporale, violazioni etiche e allucinazioni specifiche di un compito in ambiti come la generazione di codice e le applicazioni multimodali. Analizza le cause sottostanti, categorizzandole in problemi relativi ai dati, fattori relativi al modello e influenze relative ai prompt. Inoltre, il rapporto esamina i fattori cognitivi e umani che influenzano la percezione delle allucinazioni, esamina i criteri di valutazione e le metriche per il rilevamento e delinea strategie di mitigazione architetturali e sistemiche. Infine, introduce
risorse basate sul web per il monitoraggio delle release e delle prestazioni di LLM.
Il rapporto sottolinea la natura complessa e sfaccettata delle allucinazioni LLM e sottolinea che, data la loro teorica inevitabilità, gli sforzi futuri devono concentrarsi su un rilevamento robusto, sulla mitigazione e sulla continua supervisione umana per un'implementazione responsabile e affidabile in applicazioni critiche.
A differenza della definizione medica di allucinazione, che si riferisce a esperienze sensoriali in assenza di stimoli esterni, nel contesto degli LLM – afferma Cossio - indica la creazione di informazioni non fattuali per rispondere a una query dell'utente, spesso senza alcun segnale esplicito della loro natura inventata”.
“Tali contenuti generati – ci dice Cossio - sono caratterizzati come errati, privi di senso e privi di una base giustificabile, rendendo difficile la loro rilevazione per gli utenti. La prevalenza delle allucinazioni solleva preoccupazioni significative riguardo all'affidabilità e alla fiducia negli LLM, specialmente con la loro crescente integrazione nei sistemi di recupero delle informazioni (IR) e nei processi decisionali critici.
L’Intelligenza Artificiale, così come esce dallo studio dell’Università di Barcellone, non è per niente intelligente ed è del tutto inaffidabile.
Interessante anche, per altri versi, un rapporto della Rand Corporation, voce non ufficiale del Pentagono.
Il rapporto del thinktank Usa intende stimolare la riflessione tra i decisori politici sui possibili impatti dello sviluppo dell'intelligenza artificiale generale (AGI) sulla geopolitica e sull'ordine mondiale, evidenziando potenziali scenari futuri per la governance dell'AGI e i suoi effetti sulle dinamiche di potere globali.
Gli autori si concentrano su una varietà di impatti, alcuni dei quali forse improbabili ma significativi, derivanti dallo sviluppo e dall'implementazione dell'AGI, che potrebbero alterare radicalmente l'ordine geopolitico esistente.
Per stimolare la riflessione su questi potenziali impatti rivoluzionari, gli autori sviluppano otto scenari illustrativi basati sul grado di centralizzazione dello sviluppo dell'AGI e sui suoi esiti geopolitici.
Gli scenari coprono gli impatti dell'AGI che rafforzano gli Stati Uniti, rafforzano i concorrenti statunitensi, causano un significativo cambiamento geopolitico e determinano un'interruzione nello sviluppo dell'AGI.
Gli scenari sono progettati per dimostrare come il grado di centralizzazione nello sviluppo delle AGI sia un fattore determinante per gli esiti geopolitici che potrebbero concretizzarsi.
In scenari più centralizzati, sia gli Stati Uniti che un avversario potrebbero ottenere vantaggi significativi, mentre uno sviluppo decentralizzato potrebbe portare a un modello di governance multilaterale o persino a una destabilizzazione geopolitica se gli attori non statali diventassero significativamente più potenti grazie allo sviluppo delle AGI.
Il grado di centralizzazione rappresenta forse il fattore più cruciale nello sviluppo delle AGI. Uno sviluppo fortemente centralizzato favorisce le potenze consolidate con risorse consistenti; percorsi decentralizzati possono dare potere a più attori, ma aumentano i rischi di proliferazione.
Il rapporto tra Stati e industria privata emerge come un altro fattore determinante. Gli esperti sottolineano né gli Stati, né le aziende, da soli, possono governare efficacemente lo sviluppo delle AGI: una cooperazione equilibrata è essenziale.
Il rapporto affronta anche la questione fondamentale, ossia la difficoltà intrinseca di garantire che i sistemi AGI perseguano in modo affidabile obiettivi compatibili con l'uomo. Difficoltà che crea rischi significativi. La mitigazione di questo rischio richiede spesso una cooperazione internazionale volta a limitare l'accesso all'AGI da parte di attori pericolosi e a fronteggiare una perdita di controllo potenzialmente catastrofica sui sistemi.
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3034-2.html??cutoff=true&utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=7014N000001SngRQAS&utm_term=00vQK000003RkHyYAK&org=1674&lvl=100&ite=299405&lea=2762195&ctr=0&par=1&trk=a0wQK00000EImm6YAD
Dopo queste brevi considerazioni sull’intelligenza artificiale, ha un senso il finale del romanzo-saggio che ci consegna Atena, Intelligenza Artificiale Generale, voluta da Zhang Li, capace di cambiare il destino dell’umanità, oppure siamo di fronte ad uno scenario apocalittico degno di Armageddon, ossia di un’ansia catartica dell’umanità? O, quanto meno di una parte di essa?
Segue la domanda: quanto c’è, ad esempio, dell’idea di Armageddon nella propaganda Usa sull’intelligenza artificiale?
Propaganda che sfida glia altri soggetti del multipolarismo geopolitico mondiale con “tanto di manifesto: «Vincere la gara. Piano d’azione americano per l’intelligenza artificiale» varato il 23 luglio dalla Casa Bianca. L’esordio dice tutto: «Gli Stati Uniti sono in gara per conseguire il dominio globale nell’intelligenza artificiale». Rivoluzione a 360 gradi, dall’industria al digitale, in una parola: «Rinascimento». Con 19 raccomandazioni specifiche del Pentagono”. (Lucio Caracciolo, Limes 7/2025).
Interessante la coincidenza del termine rinascimento nella propaganda Usa con quella di rinascita nella descrizione delle finalità del magnate cinese che ha dato vita ad Atena nel romanzo.
L'idea di Armageddon è profondamente radicata nella mentalità culturale e religiosa degli Stati Uniti, intrecciata con la storia, la religione e la cultura popolare del paese. Deriva principalmente dall'immaginario cristiano, in particolare dal Libro dell'Apocalisse nella Bibbia, che descrive una battaglia finale tra il bene e il male. Questo concetto ha assunto una vita propria negli Stati Uniti, plasmando prospettive, narrazioni e persino decisioni politiche.
Gli Stati Uniti hanno una forte tradizione cristiana evangelica, con molti che interpretano l'Apocalisse come una profezia letterale. L'idea di Armageddon come evento escatologico risuona tra i gruppi religiosi, in particolare tra i cristiani evangelici, che vedono gli eventi mondiali (come i conflitti in Medio Oriente) come segni di un'imminente fine dei tempi.
La mentalità di Armageddon è spesso legata alla narrazione dell'eccezionalismo americano, in cui gli Stati Uniti si vedono come una forza morale in una lotta cosmica tra bene e male.
Il finale del romanzo-saggio di Angelo Gatto si colloca in questa dimensione escatologica, dove la battaglia finale tra il bene e il male non è tra gli Usa (il bene) e la Cina (il male), ma tra l’insipienza di un’umanità incapace di elevarsi (il male endemico dell’uomo) e Atena, nuova divinità tecnologica che crea un caos distruttivo dal quale può nascere una rinascita.
Il romanzo finisce con una nota di totale pessimismo nei confronti della capacità dell’essere umano di evolversi, così da mettere il suo destino non più nelle mani degli dèi dell’Olimpo, o di un Dio padre e signore, ma di un’entità artificiale.
La realtà è che la creatura, se perfettamente costruita a immagine simiglianza, conterrebbe tutte le caratteristiche del creatore e non farebbe altro che far rinascere di nuovo quanto si pensava potesse essere eliminato.
Infatti se l’Intelligenza Artificiale Generale soffre di allucinazioni, è imperfetta, mente, mette in crisi chi la vende come il futuro strumento della disumanizzazione o il transito dell’umano nel transumano.
“Altra mistificazione – scrive Dario Fabbri - è l’intelligenza artificiale, innovazione tecnicamente interessante ma assai inferiore per incidenza allo internet, eppure venduta dagli americani e dal marketing come superamento della specie umana”. (Dario Fabbri Domino, 7/2025).
Ed ecco che il rapporto tra il magnate cinese, che vuole realizzare il suo obiettivo in base all’insegnamento dell’Etica Nicomachea e la sua infuocata amante russa, che si rapporta a Shopenhauer, il quale sostiene che al di sotto della rappresentazione fenomenica ci sia, come fondamento, la volontà, presenta il confronto tra due modi di affrontare la vita, opposti e ossimoricamente coincidenti.
Il magnate cinese è disposto ad annullarsi per immedesimarsi nel suo obiettivo che, preso dell’impossibilità dell’essere umano mente-corpo-emozioni di evolversi, è una rinascita gestita da una dea tecnologica.
La mafiosa russa, nel riconoscere con Shopenhauer che il corpo non è un oggetto come gli altri, ma che è dato «come qualcosa di immediatamente conosciuto da ciascuno, e che viene designato con il nome di volontà” (Mondo), si avvia alla conclusione del filosofo che per un verso l’uomo è fenomeno, dunque è sottoposto alla legge di causalità, e non è libero; per un altro, è noumeno, ed è nuovamente asservito, non alla rappresentazione, ma alla volontà. Ne consegue che la liberazione è conseguire la noluntas, la nolontà.
Questa ha tre livelli: la giustizia che pone freno alla lotta tra gli individui, la bontà, intesa come amore e compassione e l’ascesi, con le sue caratteristiche di rassegnazione e di sacrificio.
Irrazionalismo e pessimismo e intento di soggiacere al proprio telos si accoppiano, come i due amanti, nel delegare alla dea tecnologica il futuro dell’umanità.
Cosa concludere? Forse che la via per ricomporre l’umanità sta nel superare “il «male» che – come scrive Emilio Servadio – è disunione e spezzatura, nell’uomo come nel cosmo; per cui il fine […] è restaurare a qualsiasi livello dell’ordine cosmico, la perfetta armonia, la suprema «meraviglia» della Cosa Unica”. [i] Compito non delegabile ad alcuna intelligenza artificiale.
[i] Emilio Servadio, Passi sulla via iniziatica, Edizioni Mediterranee
Il 30 luglio scorso Palo Alto Networks ha acquisito CyberArk, la società israeliana leader mondiale nella sicurezza delle identità, a cui si affidano organizzazioni di tutto il mondo per proteggere le identità umane e virtuali nelle aziende moderne.
Il 30 luglio, con un comunicato stampa, le due società, Palo Alto, leader globale nella sicurezza informatica, e CyberArk, leader globale nella sicurezza dell'identità, hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Palo Alto Networks acquisirà CyberArk.
Combinando la leadership consolidata di CyberArk nella sicurezza delle identità e nella gestione degli accessi privilegiati (PAM) con le piattaforme di sicurezza complete basate sull'intelligenza artificiale di Palo Alto Networks, la protezione delle identità privilegiate verrà estesa a tutti i tipi di identità, comprese quelle umane, quelle delle macchine e la nuova ondata di agenti di intelligenza artificiale autonomi. CyberArk si sta già affermando come piattaforma di sicurezza delle identità e Palo Alto Networks contribuirà ad accelerare questo percorso verso la piattaforma per ottenere migliori risultati di sicurezza combinata per i clienti.
CyberArk è leader mondiale nella sicurezza delle identità. La piattaforma di sicurezza delle identità basata sull'intelligenza artificiale di CyberArk applica controlli intelligenti dei privilegi a ogni identità, con prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce costanti lungo l'intero ciclo di vita dell'identità. Con CyberArk, le organizzazioni possono ridurre i rischi operativi e di sicurezza abilitando zero trust e privilegi minimi con visibilità completa, consentendo a tutti gli utenti e le identità, inclusi personale, IT, sviluppatori e macchine, di accedere in modo sicuro a qualsiasi risorsa, ovunque si trovi e da qualsiasi luogo. Per saperne di più, visita cyberark.com.
In qualità di leader globale nell'intelligenza artificiale e nella sicurezza informatica, Palo Alto Networks si impegna a proteggere lo stile di vita digitale attraverso l'innovazione continua e fornisce soluzioni di sicurezza complete basate sull'intelligenza artificiale per reti, cloud, operazioni di sicurezza e intelligenza artificiale, potenziate dall'esperienza e dall'intelligence sulle minacce di Unit 42.
Come fa notare il canale Giubbe Rosse, oltre a iniettare potenzialmente miliardi di dollari nell'economia israeliana, l'acquisizione di CyberArk da parte di Palo Alto Networks rafforza ulteriormente il rapporto tra la Silicon Valley e l'apparato di sicurezza e intelligence israeliano. Udi Mokady, fondatore e presidente esecutivo di CyberArk, è un ex allievo dell'Unità 8200, la divisione d'élite dell'intelligence dei segnali della Direzione dell'Intelligence Militare israeliana. Così come i quattro co-fondatori di Wiz, l'azienda israeliana di cloud computing recentemente acquistata da Google e per Nir Zuk, fondatore e Chief Technology Officer di Palo Alto.
L’acquisizione di CyberArk , che segue quelle di Light Cyber, Dig Security, Talon Cybersecuruty, Secdo e Bridgecrew, fondate e guidate da veterani dell'Unità 8200 identificati pubblicamente fanno pensare ad una continua integrazione tra l’intelligence statunitense e quella israeliana.
Altre importanti acquisizioni includono Cyvera, Twistlock e Puresec, i cui fondatori provengono anche dalle "unità informatiche, di intelligence e di commando" delle forze di difesa israeliane.
A giugno 2025, secondo il sito Giubbe Rosse, oltre 1.400 veterani dell'intelligence israeliana lavoravano nel settore tecnologico statunitense, di cui 900 provenienti dalla sola Unità 8200. Questo numero proviene da un database di persone che si identificano pubblicamente come ex ufficiali dell'intelligence israeliana e con un lavoro nel settore tecnologico degli Stati Uniti sui loro profili LinkedIn.
Mentre le grandi aziende tecnologiche globali si contendono i migliori ingegneri dell’intelligenza artificiale con offerte milionarie, l’Italia guarda da bordo campo. Il rischio? Non solo perdere la competizione industriale ed economica del XXI secolo, ma rimanere un semplice consumatore di tecnologie altrui, senza mai essere davvero protagonista. E questo, in uno scenario dove l’IA non sarà solo una leva industriale, ma il tessuto stesso del nostro futuro collettivo.
Negli ultimi mesi, il panorama della tecnologia ha visto un’accelerazione impressionante, nell’ambito del quale Microsoft, Google, OpenAI e un ristretto gruppo di altri attori stanno investendo cifre astronomiche, fino a milioni di euro annui per singolo profilo per assicurarsi i migliori sviluppatori, ricercatori e ingegneri con competenze elevate riguardo l’intelligenza artificiale.
Questa “guerra dei talenti” ha ormai assunto toni da strategia militare, con le le aziende si contendono non solo competenze, ma potere, poiché controllare l’IA, oggi, significa dominare le piattaforme, i dati, e i modelli cognitivi del domani.
Nel 2025, è chiaro a tutti che i modelli generativi, multimodali e auto-addestranti (come GPT-5, Claude, Gemini e le loro versioni enterprise) stanno ridefinendo interi settori quali la sanità, la giustizia, le imprese manifatturiere, la finanza e quant’altro.
Chi controlla l’innovazione, controlla il mercato. E chi controlla il mercato, influenza anche la politica e la cultura.
Ma cosa sta facendo l’Italia, in tutto questo, tra carenze strutturali, potenziale inespresso e rischi sistemici?
In Italia, i segnali sono chiari ma spesso ignorati. Il 63% degli imprenditori italiani dichiara di non trovare competenze adeguate in IA generativa.
E come potrebbe essere diverso? Siamo solo al 7° posto in Europa per offerta formativa nel campo dell’IA e al 16° tra i Paesi OCSE per diffusione delle competenze digitali avanzate.
Un dato allarmante riguarda il basso numero di laureati in discipline ICT, appena 1,4% del totale, a fronte di un’industria che si digitalizza rapidamente ma non riesce a farlo con personale interno.
Il divario tra domanda e offerta formativa cresce ogni mese.
A ciò si somma la storica emigrazione di talenti italiani verso l’estero.
Reddit e LinkedIn sono pieni di storie di giovani data scientist, ingegneri informatici e ricercatori che, dopo aver studiato in Italia, volano in Olanda, Stati Uniti o Israele per trovare ambienti di lavoro stimolanti, meritocratici e ben retribuiti.
Questo impoverisce il nostro ecosistema e riduce il capitale umano disponibile per le imprese italiane.
Il fenomeno si “autoalimenta”, meno talenti, meno startup, meno innovazione, meno occupazione qualificata e ovviamente ancora più fuga.
In termini di investimenti, l’Italia è 20ª al mondo per fondi destinati a startup e scale-up IA, la stessa spende solo l’1,5% del PIL in Ricerca & Sviluppo, molto sotto la media europea (2,3%) e lontanissima da Paesi come la Germania (~3%).
Nel frattempo, gli Stati Uniti da soli producono il 69% dei modelli di IA generativa. L’Unione Europea nel complesso, il 4%.
Il paradosso italiano è evidente, abbiamo infrastrutture come il supercomputer Leonardo, tra i più potenti in Europa, ma non abbiamo abbastanza specialisti per usarle pienamente.
Il risultato è che queste infrastrutture rischiano di diventare cattedrali nel deserto digitale.
Le PMI italiane, ossatura del nostro sistema economico sono spesso impreparate ad affrontare la trasformazione digitale guidata dall’IA.
I dati ci dicono che laddove l’IA viene introdotta, l’efficienza cresce: +5% per il 47% delle aziende, almeno +1% per il 74%. Ma le implementazioni restano sporadiche, episodiche, nei fatti mai sistemiche.
Se vogliamo davvero giocare questa partita, dobbiamo uscire dalla logica delle iniziative isolate e pensare in termini sistemici. Ecco alcune leve fondamentali da attivare subito:
formazione continua e sistemica;
Piano Nazionale di Alfabetizzazione AI, a partire dalle scuole primarie;
espansione dei corsi universitari: oggi l’Italia offre 66 corsi in IA, contro i 146 della Germania;
formazione congiunta università-imprese, con il coinvolgimento di sindacati e territori, come previsto nel piano GOL e nella Repubblica Digitale;
integrazione dell’IA nei percorsi ITS, negli Istituti Tecnologici Superiori, fondamentali per il tessuto industriale italiano.
Vanno, altresì, curati gli investimenti pubblici e privati intelligenti quali:
il sostegno diretto a startup e scale-up con strumenti di venture capital pubblico e incentivi fiscali mirati;
lo sfruttamento intelligente dei mega-investimenti: come quello di Microsoft, che investirà 4,3 miliardi di euro in due anni in Italia, con una rete di data center e un piano formativo da un milione di persone;
l’allineamento alla strategia europea: coerenza tra i fondi PNRR, Horizon Europe e investimenti privati.
Il fenomeno dovrebbe essere “governato” a livello unitario con una unica strategia unitaria, che ricomprende:
appunto una Strategia Nazionale AI integrata con il piano per l’Industria 5.0, che includa sanità, giustizia, energia, PA e manifattura;
il potenziamento dei Competence Center e creazione di poli regionali d’eccellenza;
l’istituzione di un coordinamento centrale, trasversale tra ministeri, università, imprese e pubbliche amministrazioni;
la capacità di trattenere e attrarre talenti;
introdurre incentivi per ricercatori italiani all’estero e per profili internazionali;
progetti avanzati che valorizzino i giovani in Italia, con percorsi chiari e trasparenti;
- Un piano serio per il rientro dei cervelli: meno retorica, più contratti reali e competitivi.
Il futuro dell’intelligenza artificiale non è più un’ipotesi. È un percorso già in atto, che determinerà i nuovi equilibri geopolitici, economici e culturali.
Oggi siamo di fronte a un bivio, o rientrare in gioco con una strategia nazionale ambiziosa, o rimanere spettatori di un progresso che ci scavalca.
Se non affronteremo con lucidità la questione educativa, la fuga dei cervelli, il gap di investimenti e l’assenza di una visione strategica, rischiamo di trasformare l’Italia in un Paese che consuma IA prodotta altrove, ma che non partecipa alla sua progettazione, né ai suoi benefici.
La vera sfida, insomma, non è tecnologica. È politica, educativa e culturale. E riguarda tutti noi.
Oltre 300 ragazzi hanno assistito ad una conferenza tenuta da Maurizio Colangelo e dalla Rosj Guido sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo.
Pienamente coinvolti e resi partecipi i ragazzi hanno espresso numerose domande sul tema.
Maurizio Colangelo e Rosj Guido saranno coinvolti a maggio nella selezione dei migliori temi sull’argomento presi da tutte le scuole che parteciperanno alla 18^ edizione relativa al cyberbullismo.
Il presidente della giuria sarà il giornalista Paolo Pagliaro.
RIFERIMENTI

Testata totalmente indipendente, di proprietà dell’associazione Libera Stampa e Libera Comunicazione
Sostienici per dare una libera informazione












