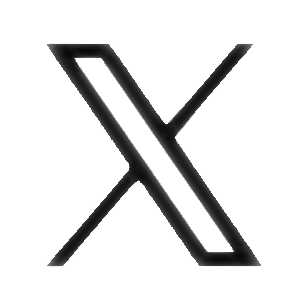Ci risiamo? Viene da chiederselo. Ogni volta speriamo sia un episodio isolato, una bravata, uno sfogo maldestro. E invece, nel profondo, sappiamo che non è così. Che questi gesti, apparentemente circoscritti, sono in realtà sintomi di qualcosa di più grande, di più inquietante.
Quando una sinagoga viene colpita, quando una targa che ricorda un bambino ebreo di due anni, ucciso in un attentato terroristico, viene imbrattata, non è solo un muro a essere ferito. È una memoria. È un’identità. È un pezzo di umanità.
“Palestina libera”, “Monteverde antisionista e antifascista”. Non semplici scritte: slogan usati come schermo, come giustificazione per un gesto che, in fondo, non parla di geopolitica ma di odio.
L’antisemitismo – lo dice bene Victor Fadlun – è diventato strumento di contestazione politica. E questo è il punto. Quando l’odio verso gli ebrei smette di abitare i margini e rientra nello spazio del dibattito politico, allora non è più un episodio. È un campanello d’allarme.È come se certe fratture storiche, mai del tutto ricucite, stessero riaffiorando.
L’antisemitismo oggi non si presenta più con la svastica in bella vista, spesso si traveste da attivismo, da ideologia, da lotta a qualcosa. Si fa liquido, come la paura. Ma il bersaglio resta lo stesso: la comunità ebraica, vista non come persone, famiglie, bambini che vanno a pregare e a vivere, ma come simbolo da colpire, da intimidire, da usare.
Sporcare la targa di un bambino morto in un attentato è un gesto che va oltre la provocazione. È la volontà di cancellare la memoria, di negare la sofferenza, o forse peggio, di renderla insignificante. Perché se la memoria smette di essere condivisa, se diventa memoria “di qualcuno”, allora diventa vulnerabile.
E in tutto questo, il clima sociale conta. La polarizzazione, i social che amplificano, l’assenza di linguaggi comuni. Ogni conflitto lontano diventa immediatamente nostro, ma non perché lo comprendiamo, bensì perché lo usiamo.
La guerra diventa slogan, il dolore diventa vernice spray. Eppure, colpire una sinagoga – lo ha detto bene il presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun - significa negare il diritto alla normalità. Non solo agli ebrei, ma a tutti. Perché se un luogo di preghiera, incontro, educazione, comunità non è più inviolabile, allora nulla lo è.
Il rischio è che ogni identità diventi sospetta, ogni diversità diventi provocazione. Questi fatti non sono un caso isolato, ma nemmeno un punto di non ritorno. Sono segnali. Segnali che ci obbligano a interrogarci, a fare vigilanza culturale, a distinguere tra protesta e odio, tra opinione e violenza simbolica.
Non basta condannare: serve capire, educare, ricucire.La speranza? È fragile, ma c’è. Sta nel fatto che quella targa è stata subito ripulita. Che qualcuno ha sentito il bisogno di restituire dignità a quel nome, a quel bambino. Che la comunità non si è chiusa, ma ha parlato, ha chiesto protezione sì, ma anche rispetto. Sta nel fatto che ogni volta che qualcuno cancella, altri provano a riscrivere. A ricordare.
Il futuro dipenderà da come sapremo raccontare queste cose. Non come cronaca, ma come storia. Non come rabbia, ma come responsabilità. Perché – e questo è il punto – l’antisemitismo non è un problema degli ebrei. È un problema della società, di tutti noi. E quando lo capiamo, forse, smettiamo di dire “ci risiamo” e cominciamo a dire “non più”.