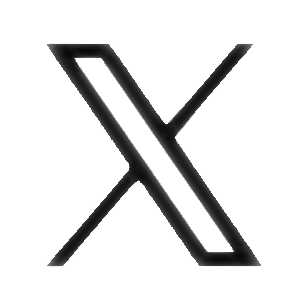di Giuseppe Gagliano *
Venezuela. Gli Usa sequestrano una petroliera nell’Oceano Indiano. Un abbordaggio lontano da casa, ma non lontano dalla politica.
Il sequestro della petroliera Aquila II nell’Oceano Indiano, annunciato da Washington il 9 febbraio 2026, racconta più di un semplice episodio di interdizione marittima. È un messaggio operativo: gli Stati Uniti intendono far valere il proprio regime sanzionatorio contro il Venezuela non solo nel bacino caraibico, dove la questione nasce, ma lungo le rotte globali. Il fatto che l’abbordaggio sia avvenuto nell’area di responsabilità del Comando Indo-Pacifico chiarisce un punto: la geografia non è più un limite, è un moltiplicatore. Se una nave sospettata di violare le sanzioni prova a “sparire” cambiando rotta e teatro, Washington vuole dimostrare di poterla raggiungere ovunque.
L’operazione, condotta senza incidenti, è stata presentata come esercizio di strumenti previsti dal diritto marittimo internazionale quando esiste il sospetto di violazioni sanzionatorie: diritto di visita, interdizione, controllo a bordo. Qui sta il cuore politico della vicenda. Il confine tra polizia dei mari e pressione strategica si fa sottile: la sanzione non resta più un atto amministrativo o finanziario, diventa un gesto fisico, navale, visibile.
Negli ultimi mesi Washington ha irrigidito l’azione contro il traffico petrolifero riconducibile a Petroleos de Venezuela, sostenendo l’esistenza di una “flotta oscura” che aggirerebbe le restrizioni con strumenti ormai noti: bandiere di comodo, spegnimento dei sistemi di identificazione automatica, rotte indirette per confondere origine e destinazione del carico. Il caso Aquila II si inserisce in questa narrazione e la rafforza: la nave, secondo fonti del Pentagono, avrebbe provato a sottrarsi al controllo proseguendo la navigazione nonostante misure di quarantena applicate alle unità sanzionate, segnale di una partita a guardie e ladri che si gioca sull’oceano, non nei palazzi.
Il precedente di dicembre 2025, ovvero il sequestro della nave Skipper dopo la partenza dal Venezuela, e le azioni di inizio gennaio 2026 tra Atlantico settentrionale e Caraibi, con fermi multipli e casi di cambio di bandiera durante la navigazione, indicano un cambio di passo: non più solo minacce legali, ma interruzione fisica delle catene logistiche. Caracas, prevedibilmente, ha reagito parlando di pirateria internazionale, perché sul piano della comunicazione interna il Venezuela ha bisogno di trasformare la vulnerabilità economica in aggressione esterna.
Sul piano strategico-militare, l’elemento più interessante non è tanto l’abbordaggio in sé, quanto il teatro scelto e la cornice con cui viene raccontato. Il Pentagono lo descrive come prova di proiezione globale: la capacità di operare in mari lontani per far rispettare una decisione politica. In altre parole, una forma di “maritime enforcement” che assomiglia sempre di più a un dispositivo di potenza: presenza navale, sorveglianza, tracciamento prolungato della rotta, intervento al momento opportuno.
Qui emerge un secondo livello: l’intreccio tra interdizione anti-sanzioni e missioni più ampie nei Caraibi e sulle rotte strategiche, comprese operazioni contro imbarcazioni più piccole sospettate di narcotraffico. Washington lega i due dossier con un filo unico: interrompere flussi finanziari che alimenterebbero reti criminali e strutture statali ostili. È una costruzione coerente dal punto di vista americano: petrolio sanzionato e droga non sono fenomeni separati, ma circuiti che producono liquidità e potere. La conseguenza, però, è che lo strumento militare finisce per diventare la cerniera tra politica estera e ordine pubblico globale.
Sul piano geoeconomico, la strategia appare doppia. Da un lato si colpiscono le navi e le reti logistiche per rendere più costoso, rischioso e lento esportare greggio venezuelano. Dall’altro, si mantiene un canale selettivo con Chevron, l’unica grande compagnia statunitense ancora operativa in Venezuela grazie a una licenza speciale dell’ufficio del Tesoro che consente transazioni limitate legate all’importazione di greggio venezuelano. È un equilibrio tipicamente americano: pressione forte per tenere Caracas sotto stress, ma una valvola di controllo per non perdere del tutto leva economica e tecnica sul settore energetico.
L’incontro dell’incaricata d’affari statunitense a Caracas, Laura Dogu, con i rappresentanti di Chevron viene presentato come tassello di un approccio pragmatico: discutere prospettive economiche e ruolo dell’energia in un’eventuale stabilizzazione. Tradotto: si vuole impedire che il Venezuela trovi ossigeno autonomo fuori dal perimetro controllabile, ma si vuole anche evitare un collasso che destabilizzi ulteriormente l’area o consegni definitivamente il settore ad attori concorrenti.
Nel breve periodo, la stretta sulle petroliere spinge verso tre effetti prevedibili. Primo, aumenta il “premio di rischio” sul trasporto: assicurazioni, noli, triangolazioni e coperture diventano più care. Secondo, cresce la segmentazione dei mercati: chi compra greggio venezuelano dovrà farlo accettando zone grigie e complessità operative. Terzo, aumenta l’incentivo a usare intermediari, cambi di proprietà e registrazioni opache, cioè a trasformare il commercio in un labirinto.
Nel medio periodo, però, la partita vera è politica: se Washington riesce a rendere inefficiente la rete di export venezuelana senza rompere il canale controllato con Chevron, può tenere Caracas in una condizione di dipendenza e vulnerabilità. Se invece la pressione navale viene percepita come eccessiva, può accelerare la saldatura del Venezuela con reti alternative e protettori esterni, rafforzando i circuiti paralleli che le sanzioni vorrebbero spezzare.
Questa vicenda parla anche al resto del mondo. L’idea che una decisione sanzionatoria possa tradursi in abbordaggi e sequestri in alto mare è un segnale per chiunque fondi la propria resilienza su rotte energetiche e logistica. È un messaggio ai Paesi che commerciano con Caracas, ma anche a quelli che osservano: le sanzioni non sono soltanto un elenco su un documento, possono diventare azione militare, con un costo politico e con rischi di escalation diplomatica.
Non è un caso che il teatro sia l’Indo-Pacifico: un’area dove la competizione tra potenze si gioca anche sul controllo delle rotte e sulla credibilità della presenza navale. Portare lì un caso “venezuelano” significa dire che la rete americana è unica, interconnessa, e che la proiezione marittima resta il cardine della sua capacità di imporre regole.
Il sequestro della Aquila II non è solo un episodio. È un tassello di una strategia di coercizione calibrata: colpire l’economia venezuelana dove fa più male, cioè nel petrolio e nei flussi che lo portano sul mercato, senza chiudere del tutto i canali che consentono a Washington di mantenere influenza e informazioni sul terreno. Il rischio, per gli Stati Uniti, è trasformare la sanzione in una routine militare e quindi in una fonte permanente di frizione internazionale. Il rischio, per il Venezuela, è restare intrappolato tra retorica sovranista e dipendenza economica, in un gioco dove il mare diventa il luogo in cui si misura la forza reale degli Stati, non quella dichiarata.
* in collaborazione multimediale con Notizie Geopolitiche