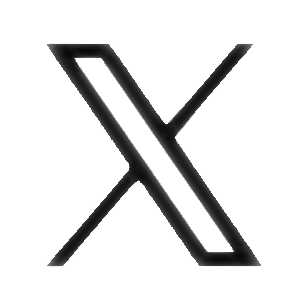di Marco Palombi
L’attuale instabilità in Iran, osservata al 5 gennaio 2026, va letta come un passaggio critico nella traiettoria dell’Islam politico non perché introduca elementi inediti, ma perché rende osservabile, in forma concentrata, un processo di lungo periodo: la religione, concepita come infrastruttura operativa della sovranità, della legittimazione e del controllo, mostra segni di erosione funzionale proprio nel punto in cui era stata progettata per essere inattaccabile, cioè nella trasformazione dell’ordine morale in obbedienza politica.
Quando il sacro è architettura di Stato, esso non vive soltanto nei rituali o nella dottrina: vive come grammatica dell’ovvio, come cornice che rende “naturale” ciò che altrimenti apparirebbe negoziabile. La frattura, oggi, non riguarda l’esistenza della religione come fatto sociale, ma la sua capacità di operare come tecnologia unificante dell’autorità. Le proteste diffuse in 17–21 province, originate da shock economici percepiti come non più assorbibili (inflazione elevata, svalutazione della valuta, aumento dei costi della vita), vanno quindi trattate come sintomo e rivelatore: non semplice congiuntura economica, ma test di resistenza di un dispositivo teologico-politico che, quando perde presa simbolica, tende a rivelare la propria natura strumentale.
La composizione e le forme della protesta sono coerenti con questa diagnosi. La partecipazione di segmenti sociali diversi (commercianti, studenti, proprietari di negozi in scioperi), la diffusione rapida e le pratiche simboliche di sfida (danni a simboli del potere, gesti di profanazione contro elementi percepiti come statuali) indicano che la contestazione non è localizzata né sociologicamente confinata: attraversa la società come un fenomeno di disallineamento morale. In un sistema in cui il sacro era stato incorporato per trasformare conflitto in disciplina e dissenso in colpa, la protesta non è soltanto domanda di redistribuzione, ma rifiuto della cornice che rendeva legittima la disciplina stessa.
Non è l’economia, qui, a produrre automaticamente politica; è l’economia a “svelare” il carattere contrattuale e non trascendente dell’obbedienza. È questo il punto di transizione: la religione smette di funzionare come meccanismo coercitivo di obbedienza e diventa un orizzonte morale contestato, in cui l’asse della legittimità tende a scorrere verso dignità individuale e autonomia, non più verso gerarchia e dovere.
La risposta del regime rende questa dinamica ancora più leggibile perché mostra la sostituzione progressiva di una risorsa simbolica con una risorsa coercitiva. L’impiego di munizioni letali, gas lacrimogeni e cannoni ad acqua (in un contesto di stress idrico), i sorvoli di elicotteri e le interruzioni parziali di internet esemplificano un modello di controllo che si irrigidisce quando la persuasione si indebolisce.
Qui il nodo è strutturale: quando l’autorità simbolica declina, l’ordine tende a essere mantenuto tramite coercizione crescente. Ma nel caso iraniano ciò è più grave che altrove, perché il dispositivo di legittimazione è teologico-politico: la Velayat-e Faqih, trasformando la giurisprudenza sciita in architettura statale, aveva reso la gerarchia non solo un fatto amministrativo, ma una necessità morale. Il paradosso è che l’intensificazione coercitiva, quando non è più coperta da un consenso simbolico diffuso, rende visibile il carattere operativo del sacro. E quando il sacro appare come strumento, diventa profanabile. La profanazione, in questo senso, non è un gesto anticlericale in senso stretto: è l’atto con cui si nega che l’ordine statale possieda una qualità trascendente.
A questa vulnerabilità si sommano variabili strutturali che accelerano l’erosione dell’infrastruttura sacrale come tecnologia politica. Urbanizzazione oltre il 75%, alfabetizzazione giovanile quasi universale e piattaforme digitali che abbassano i costi della competizione narrativa frammentano i discorsi unificati e moltiplicano i registri interpretativi. In tale contesto, la “santità” dell’ordine non può più essere trasmessa come certezza implicita e indiscussa: deve competere. Ma la competizione è, per definizione, desacralizzante, perché trasforma un orizzonte in un’opinione. Ne deriva una fatica cognitiva: la ripetizione di frame ufficiali, quando non è più credibile, non produce rassicurazione ma irritazione, non produce coesione ma disallineamento, perché costringe la mente sociale a gestire una dissonanza costante tra esperienza materiale e linguaggio pubblico. È in questa frizione che la legittimità si consuma più rapidamente: non per assenza di religiosità, ma per sovra-esposizione di una retorica che non riesce più a totalizzare.
Le vittime riportate, stimate nell’ordine di circa una ventina individui fra manifestanti e forze di sicurezza, e gli arresti (circa un centinaio), introducono un ulteriore meccanismo di inversione morale. In un contesto di crisi del sacro come risorsa unificante, la violenza non produce sacralizzazione dell’ordine ma, spesso, sacralizzazione della vittima. La repressione non “ripara” l’autorità: la espone. Qui la lettura girardiana è pertinente: quando il dispositivo sacrificale non viene più percepito come fondazione pacificante dell’ordine, ma come atto di potere, esso smette di contenere la violenza e diventa generatore di delegittimazione. La vittima non chiude il conflitto: lo apre, perché diventa prova materiale che l’autorità non persuade più e dunque deve colpire.
Anche le mosse interne sono coerenti con un sistema in modalità di sopravvivenza e con i limiti della governance sacrale. La sostituzione del capo della banca centrale, l’ipotesi di ristrutturazioni securitarie con nomine più dure, e la gestione delle università tramite strumenti di controllo “amministrativo” (come l’imposizione dell’apprendimento remoto sotto pretesti non politici) indicano adattamenti pragmatici che, tuttavia, hanno un costo: rendono trasparente l’operatività del potere. Se l’autorità è presentata come mandato divino, ogni intervento tecnico che appare come mera gestione della crisi rischia di “svelare” che ciò che si dice trascendente è, in pratica, amministrato. E quando il sacro scivola a eco retorico, esso continua a essere pronunciato, ma perde la capacità di produrre obbedienza spontanea: diventa linguaggio di copertura di una macchina che cerca di contenere, non di integrare.
Sul piano esterno, la cornice dell’assedio continua a funzionare come supporto alla coesione del regime, ma mostra limiti crescenti come tecnologia di mobilitazione totale. Eventuali segnali di sostegno da alleanze geopolitiche (ad esempio cargo russi interpretati come supporto) e la comunicazione di attività missilistiche incorniciate come esercitazioni rafforzano l’idea di minaccia esterna; tuttavia, se la regione si muove verso una relativa de-escalation, il potere mobilitante dell’assedio si riduce. Ne deriva un paradosso: la teologia dell’assedio resta utile perché offre una spiegazione totale, ma diventa meno efficace nel trasformare sofferenza economica in obbedienza, perché la sofferenza è vissuta come interna e strutturale, non come incidente prodotto esclusivamente dal nemico.
A livello internazionale, le dichiarazioni del Presidente statunitense Donald Trump contro la violenza e a favore dei manifestanti, e gli appelli di figure dell’opposizione come Reza Pahlavi, amplificano la contestazione domestica. Questi fattori esterni non creano da soli l’instabilità, ma possono accelerare la rilocalizzazione della “santità” dall’obbedienza statale alla sovranità personale.
Il punto non è l’influenza diretta, ma l’effetto di risonanza: la protesta iraniana viene inscritta in un contesto più ampio in cui l’Islam politico, da forza monopolistica di unità, tende a diventare performativo e polarizzato in società connesse, dove la competizione narrativa riduce la capacità dello Stato di definire unilateralmente che cosa sia sacro, che cosa sia legittimo, e che cosa sia obbedienza. In questa condizione, il sacro non sparisce: cambia di lato. E quando cambia di lato, la stessa architettura che lo aveva reso strumento di dominio può convertirsi in moltiplicatore della contestazione.
Questo quadro consente ora di chiarire un punto cruciale: se e in quale misura le proteste in corso possano essere interpretate come una ripetizione della Rivoluzione del 1979, oppure come un fenomeno di natura radicalmente diversa. La risposta, alla luce dei dati e delle dinamiche osservate, è netta. Le analogie sono prevalentemente superficiali e tattiche; le differenze sono strutturali e strategiche.
Nel 1979, l’infrastruttura sacrale non era in crisi, ma in fase di espansione. La religione sciita fungeva da linguaggio comune, da collante interclassista e da tecnologia di mobilitazione capace di trasformare il dissenso in progetto di potere. Il sacro operava come dispositivo ordinante: forniva un nemico identificabile, una teleologia storica, una promessa di giustizia e un’autorità carismatica in grado di unificare segmenti sociali differenti sotto un’unica grammatica politica. In quel contesto, la violenza rivoluzionaria non delegittimava il movimento, ma lo consacrava, secondo una logica girardiana in cui il sacrificio fondativo rigenera l’ordine e produce consenso.
Le proteste del 2025–2026 si collocano invece all’estremo opposto di questo ciclo. Esse emergono in un sistema in cui l’infrastruttura sacrale è già stata pienamente istituzionalizzata, consumata e progressivamente svuotata della sua funzione unificante. Il sacro non precede più l’azione politica come principio ordinatore, ma viene richiamato in modo reattivo, difensivo, spesso strumentale, da un regime che ne dipende per giustificare la coercizione, non per generare adesione. In questo senso, la violenza statale non consacra l’ordine, ma ne accelera la delegittimazione, trasformando le vittime in simboli morali contro il potere, anziché a suo sostegno.
Da qui deriva la differenza decisiva nella direzione del conflitto. Nel 1979, la religione fu il veicolo attraverso cui si costruì un nuovo Stato. Oggi, la contestazione investe direttamente quella stessa architettura teocratica. Gli slogan, i riferimenti simbolici e la pluralità delle narrazioni – incluse quelle monarchiche, nazionaliste o apertamente post-religiose – indicano che il sacro non funge più da monopolio semantico, ma da campo di conflitto. L’Islam politico, da tecnologia di integrazione, diventa oggetto di disputa e, in alcuni casi, di rigetto.
Questo passaggio spiega perché l’attuale instabilità non produca una dinamica rivoluzionaria classica, ma una condizione di instabilità cronica. Le proteste sono ampie ma frammentate, persistenti ma prive di una teleologia condivisa, intense ma incapaci – almeno allo stato attuale – di generare un’alternativa istituzionale coerente. Il regime, dal canto suo, non crolla, ma sopravvive in modalità difensiva, sostituendo progressivamente il consenso con la gestione amministrativa della crisi, la repressione selettiva e il ricorso a narrative di assedio sempre meno performative.
In questa prospettiva, le proteste del 2026 non sono la replica del 1979, ma la sua inversione storica. Esse segnano il punto in cui l’infrastruttura sacrale, una volta motore della costruzione statale, diventa un vincolo, un residuo simbolico che il regime non può abbandonare senza dissolversi, ma che non riesce più a mobilitare senza polarizzare contro di sé. È in questo spazio – tra capacità di coercizione intatta e capacità di significazione erosa – che si colloca l’Iran contemporaneo: non in una fase rivoluzionaria ascendente, ma in una lunga transizione post-teocratica, ancora priva di un esito definito, ma ormai strutturalmente distinta dal mondo che nel 1979 aveva reso possibile la rivoluzione.
A conclusione, va precisato che l’autore di questo articolo ha recentemente dato alle stampe il volume The Becoming of the Iranian Revolution and the New Geopolitics of Islam, un lavoro interamente dedicato all’Iran, alla costruzione della sua teocrazia come architettura di potere e al suo divenire storico e politico. Nel l’Iran non viene analizzato come anomalia contingente, ma come laboratorio avanzato di trasformazione dell’Islam in infrastruttura statuale, capace di tradurre il sacro in sovranità, apparati e coercizione, e al tempo stesso esposto, proprio per questo, a una progressiva erosione della sua capacità totalizzante. Gli eventi osservabili tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 si collocano pienamente all’interno delle traiettorie già ricostruite nel libro: la crisi del monopolio simbolico del sacro, la dissincronia crescente tra legittimità e capacità coercitiva, la trasformazione della velayat-e faqih da promessa di governo della legge a dispositivo di sopravvivenza del sistema, e il passaggio verso una stabilità fondata sempre meno sul significato condiviso e sempre più sull’amministrazione della forza. In questo senso, ciò che oggi accade in Iran non va letto come evento eccezionale, ma come conferma empirica di un processo analizzato dall’autore ex ante: il divenire di una teocrazia che continua a reggere come apparato, ma che fatica sempre più a reggere come orizzonte morale.
Il libro “The Becoming of the Iranian Revolution and the New Geopolitics of Islam: How the Iranian Revolution Changed the Face of Social and Political Islam and Why That Islam is Changing Everywhere” di Marco Palombi e’ disponibile qui https://amzn.eu/d/5uSTss3