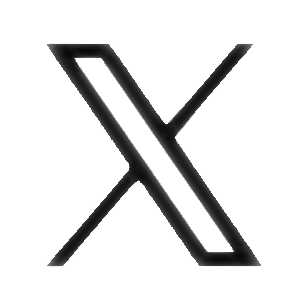Geopolitica in 64 caselle perché la storia conta più degli algoritmi
Ci sono giochi che attraversano i secoli senza invecchiare perché non sono soltanto passatempi ma strutture mentali, e gli scacchi appartengono a questa categoria rara, essendo insieme simulazione del conflitto, esercizio di previsione e pedagogia del potere, una forma compatta di strategia che ha accompagnato la trasformazione delle civiltà dall’antico subcontinente indiano fino all’Europa moderna e che ancora oggi continua a offrire una grammatica per comprendere l’ordine e il disordine del mondo.
Nati come rappresentazione simbolica delle quattro componenti dell’esercito, gli scacchi non hanno mai smesso di riflettere il modo in cui le società concepiscono la guerra e la decisione politica, e quando tra Quattrocento e Cinquecento la regina divenne il pezzo più potente della scacchiera non fu soltanto un cambiamento regolamentare ma il segno di un’epoca in cui la velocità dell’azione e la centralità del comando si stavano ridefinendo dentro un’Europa attraversata da monarchie forti, competizione dinastica e nuove geometrie del potere. Nel XIX secolo, mentre si consolidavano gli Stati nazionali e prendeva forma la guerra industriale, gli scacchi si trasformarono in disciplina teorica, in laboratorio sistematico di concetti come spazio, tempo, coordinamento e sacrificio posizionale, e i grandi maestri di quell’epoca non furono soltanto campioni ma interpreti di un pensiero lungo, capaci di dimostrare che la vittoria non dipende dalla forza isolata di un pezzo bensì dall’armonia dell’insieme e dalla capacità di anticipare l’intenzione dell’avversario.
È su questo terreno che nel Novecento si è inserita la macchina, prima come curiosità sperimentale e poi come protagonista di una trasformazione irreversibile, perché nel momento in cui un calcolatore è stato in grado di esplorare milioni di varianti in pochi secondi si è aperta una frattura nella percezione stessa dell’intelligenza, e ciò che per secoli era stato considerato dominio esclusivo della mente umana è diventato terreno di competizione con un’entità capace di profondità tattica pressoché illimitata. Quando nel 1997 il supercomputer Deep Blue sconfisse il campione del mondo Garry Kasparov non si trattò soltanto di una partita perduta ma di uno spartiacque culturale, la dimostrazione che la potenza di calcolo poteva prevalere sulla più raffinata intuizione umana, e da quel momento la relazione tra uomo e macchina negli scacchi si è fatta sempre più ibrida, con motori capaci di apprendere, sperimentare, generare linee che nessuna tradizione aveva immaginato.
Eppure proprio Kasparov, l’uomo che ha vissuto sulla propria pelle la sconfitta simbolica dell’intelligenza umana davanti alla macchina, è oggi tra le voci più ferme nel sostenere che la tecnologia non può sostituire la responsabilità politica e la memoria storica, e nel contesto della guerra in Ucraina ha assunto una posizione nettamente schierata a favore di Kiev, criticando duramente quelle proposte di soluzione rapida che, pur presentandosi come pragmatiche o tecnicamente razionali, rischiano a suo giudizio di tradursi in concessioni strutturali a vantaggio dell’aggressore. Kasparov, cittadino russo e croato che vive negli Stati Uniti, da anni oppositore dichiarato del Cremlino, legge il conflitto non come un problema di ottimizzazione dei costi ma come una partita strategica di lungo periodo nella quale l’Occidente non può permettersi cedimenti psicologici prima ancora che territoriali, perché in una posizione complessa la prima concessione non è mai neutrale ma altera l’equilibrio complessivo e apre linee di pressione difficilmente richiudibili.
Quando l’imprenditoria tecnologica globale, incarnata da Elon Musk, ha avanzato ipotesi di negoziazione e soluzioni orientate a congelare il conflitto, la reazione di Kasparov è stata netta, non contro la tecnologia in sé ma contro l’illusione che l’analisi algoritmica e la ricerca di un equilibrio immediato possano sostituire la comprensione della natura politica e storica dell’aggressione russa, perché a suo avviso la guerra non è una sequenza di dati da bilanciare bensì un confronto di volontà nel quale la memoria e la credibilità contano quanto, se non più, delle risorse materiali. Qui si manifesta la tensione decisiva del nostro tempo, da un lato la fiducia nella capacità degli algoritmi di modellizzare scenari complessi e individuare soluzioni efficienti, dall’altro la consapevolezza che la geopolitica si muove dentro stratificazioni di storia, identità e simboli che non possono essere compressi in una formula matematica, e che una tregua ottenuta senza affrontare le cause profonde del conflitto può trasformarsi in una debolezza permanente.
La metafora delle sessantaquattro caselle acquista allora un significato ulteriore, perché in una partita complessa non si sacrifica materiale senza una compensazione strutturale, non si accetta una posizione inferiore confidando nella benevolenza dell’avversario, non si confonde la sospensione temporanea delle ostilità con la stabilità duratura, e soprattutto si comprende che il tempo è un’arma tanto quanto la forza.
L’intelligenza artificiale eccelle nel calcolo delle varianti ma resta priva di esperienza storica, non percepisce il peso di un’umiliazione nazionale, non misura la portata simbolica di un confine violato, non avverte la memoria dei conflitti precedenti che orienta le decisioni dei leader e delle opinioni pubbliche, e proprio per questo la sua potenza deve essere integrata, non idolatrata, dentro una visione strategica più ampia.
Le sessantaquattro caselle non sono soltanto un quadrato ordinato ma la rappresentazione di un ordine limitato entro cui si esercita la libertà della decisione, e ricordano che ogni mossa modifica l’insieme, che ogni concessione produce conseguenze nel tempo, che ogni scelta politica è inscritta in una storia che la precede e la giudica, e che nell’era dell’intelligenza artificiale la vera sfida non è delegare la strategia agli algoritmi ma saperli governare senza smarrire la memoria da cui dipende la nostra capacità di decidere.