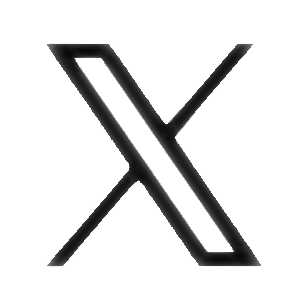Perché il giusto processo non è un lusso, ma l’antidoto alla tirannia
Nel dibattito pubblico, l’espressione “giusto processo” risuona spesso come un tecnicismo, un privilegio garantista, quasi una complicazione per il corso della giustizia. Si evoca, di solito, solo di fronte a clamorosi casi penali, come se fosse un capitolo riservato ai manuali degli avvocati.
Niente di più fuorviante, e pericoloso.
Perché il cuore dell’articolo 111 della Costituzione batte per ogni cittadino, in ogni stanza dove si amministra la giustizia. Non è un optional per pochi, ma il fondamento di una democrazia matura.
È la barriera che separa il diritto dalla prevaricazione, l’equità dall’arbitrio. In una sola, lapidaria verità: la giustizia non è, e non deve mai diventare, la legge del più forte.
È, al contrario, la sublime affermazione che anche il più forte è soggetto alla legge.
Questo principio cardinale non conosce distinzioni di ambito.
Rivela la sua potenza egualmente nel tribunale penale, dove lo Stato accusa, e in quello civile, dove si decidono controversie tra privati.
È presente nel silenzio ovattato di un’aula di giustizia amministrativa, dove il cittadino sfida un atto della pubblica amministrazione, e in quello contabile, dove si vagliano i conti della res publica.
Parla, in definitiva, del modo in cui il potere – in qualsiasi forma si manifesti, sia esso statale, economico o burocratico – si confronta con la persona.
Stabilisce le regole di un confronto che, per sua natura, è sempre asimmetrico: da un lato spesso c’è la macchina organizzata di un apparato, dall’altro la singolarità di un individuo, di un’impresa familiare, di un lavoratore.
Proprio per sanare questa asimmetria originaria esiste il giusto processo.
La sua funzione non è proteggere “qualcuno in più”, come talvolta si lascia intendere con tono polemico.
La sua missione è ben più alta e necessaria: limitare il potere.
Imbrigliarlo in un rituale di garanzie, renderlo trasparente, sottoporlo a regole che ne impediscano l’abuso.
Per questo, ogni retorica che celebra i “pubblici ministeri forti”, i “giudici forti” o gli “apparati forti” tradisce lo spirito del costituzionalismo.
In un sistema che aspiri a dirsi civile, non conta la forza delle parti in campo, ma la forza delle regole che le governano.
È la robustezza delle procedure, la loro inflessibilità, a garantire che il processo sia un luogo di diritto, non di mera contesa.
Un processo si eleva a “giusto” solo quando si realizza una sinfonia di condizioni precise e imprescindibili.
Le parti devono potersi confrontare su un piano di sostanziale eguaglianza, con eguali opportunità di essere ascoltate, di produrre prove, di controbattere le altrui argomentazioni.
Il giudice deve incarnare un’indipendenza ferrea dalle pressioni del potere politico o economico, e un’imparzialità di giudizio che sia percepibile e incontestabile.
Il tempo della decisione non può essere né un’arma logorante per una parte, né una fuga nell’eterno: deve scorrere con ragionevolezza, rispettando sia l’urgenza della giustizia che la necessità di una ponderata valutazione.
Infine, la sentenza non può essere un oracolo incomprensibile: deve essere motivata, ovvero deve rivelare il percorso logico che ha condotto a quella conclusione, rendendosi così controllabile, criticabile, eventualmente impugnabile.
Difendere l’articolo 111, allora, non è un esercizio accademico o una battaglia di casta.
È difendere una verità semplice, quasi banale, eppure costantemente minacciata dall’urgenza, dalla semplificazione, dalla tentazione di sostituire alle garanzie l’efficienza brutale.
È ricordare che la giustizia non è un servizio per far vincere sistematicamente i potenti, i meglio organizzati, i più rumorosi.
È, al contrario, l’ingegnoso meccanismo istituzionale concepito per impedire che la forza – sia essa politica, economica o mediatica – si travesta da diritto.
È il baluardo che protegge il singolo, la minoranza, la voce fuori dal coro, dall’essere schiacciati dal peso schiacciante di un potere incontrollato.
In un’epica dove le narrazioni dominanti cercano spesso eroi e potenti, il giusto processo ci ricorda che il vero eroe democratico è la procedura.
È il rituale che umilia la prepotenza e nobilita la ragione.
Ogni volta che un cittadino si presenta davanti a un giudice, non sta chiedendo un favore.
Sta reclamando l’applicazione di quel patto sociale che ci rende uguali davanti alla legge.
Sta esercitando il diritto a non essere sopraffatto.
In quella stanza, la Costituzione respira.
E ci ricorda che la forza più duratura non è quella che vince oggi una causa, ma quella che preserva, per tutti e per sempre, le regole del gioco.
Perché quando quelle regole vacillano, a perdere non è solo la parte soccombente, ma l’intera comunità, che smarrisce la fiducia nell’unico strumento che può civilizzare il conflitto e trasformare la forza bruta in diritto condiviso.

OPINIONI

Il giusto processo non è un lusso
RIFERIMENTI

Testata totalmente indipendente, di proprietà dell’associazione Libera Stampa e Libera Comunicazione
Sostienici per dare una libera informazione