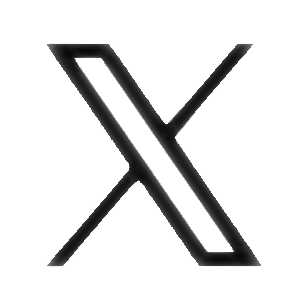Si immagini l’Italia — esercizio puramente fantascientifico — in cui un ministro dell’Università, poniamo la Bernini, decida un mattino di fare ciò che in Grecia è già accaduto davvero: prendere atto che lo studente fuori corso non è una categoria metafisica, ma una condizione amministrativa, e che l’università non è un diritto perpetuo bensì un’istituzione finalizzata allo studio. E agisca di conseguenza.
Ad Atene lo Stato non ha discusso, non ha aperto tavoli, non ha convocato assemblee permanenti. Ha contato. Ha scoperto che circa trecentomila iscritti antecedenti al 2017 figuravano ancora nei registri delle università pubbliche senza dare segni di vita accademica da anni, talvolta da decenni. Ha verificato che solo poco più del dieci per cento fosse in grado di dimostrare una minima attività: un esame, una tassa, un gesto umano riconducibile allo studio. E poi ha cancellato tutti gli altri.
Fine.
Quegli studenti erano il prodotto di una singolare ideologia amministrativa chiamata “apprendimento permanente”, una formula che in Grecia, come spesso accade, aveva smesso di indicare un’idea nobile per designare un alibi eterno. Iscrizioni mantenute nonostante interruzioni infinite, sospensioni senza termine, carriere congelate come mammut nel permafrost. Ora una legge ha messo fine all’equivoco: l’università non è un deposito, ma un percorso. Chi cammina resta, chi si ferma esce.
Il risultato è stato brutale e aritmetico: elenchi dimezzati in venticinque atenei pubblici, corsi finalmente pianificabili, risorse riallocate, lauree che tornano ad avere un peso specifico. Il tutto in un Paese dove l’università è finanziata dallo Stato e dove gli studenti europei non pagano tasse. Dunque, nessuna repressione classista, nessuna cassa da tutelare: solo un principio di realtà.
Ora, se una misura del genere fosse annunciata in Italia, il calendario civile subirebbe un’immediata modifica. Il primo venerdì utile diventerebbe “giornata di lotta”. Sciopero generale contro la cultura del merito, contro l’autoritarismo del tempo, contro l’odioso concetto secondo cui per restare studenti occorre studiare. I cortei parlerebbero di diritto negato, di esclusione sociale, di violenza simbolica. Qualcuno rispolvererebbe persino la parola “fascismo”, che in questi casi funziona come il bicarbonato: va bene su tutto.
I centri sociali ribollirebbero di fuori corso storici, veterani dell’immatricolazione, pronti a occupare università che non frequentano da anni ma che sentono proprie come un’eredità morale. I talk show si popolerebbero di sguardi severi e indignazioni rituali. Si chiederebbero spiegazioni al governo, meglio se con sottotitoli, per garantire la comprensione anche a chi confonde i crediti formativi con quelli al consumo. Qualcuno troverebbe perfino un colpevole esterno, possibilmente americano, perché la colpa, si sa, deve sempre stare altrove.
Nel frattempo, tra i rettori più inclini all’attivismo, qualcuno inizierebbe a sudare freddo: meno iscritti nominali significa meno potere simbolico. E qualche docente che ha scambiato la cattedra per un pulpito politico scoprirebbe improvvisamente che l’università, privata della folla inerte, torna a misurare anche la qualità di ciò che vi si insegna.
Ma nulla di tutto questo accadrà. L’Italia non è la Grecia. Qui lo studente fuori corso non è un’anomalia: è una figura antropologica. Una vocazione, talvolta una carriera. L’università non scandisce il tempo, lo sospende. Chi entra non esce: si trasforma, al massimo, in un’iscrizione perpetua.
E così accade che chi crede ancora nei tempi, nei percorsi, nella laurea come strumento di crescita reale, venga schiacciato dall’inerzia del sistema e finisca per cercare altrove ciò che qui è stato diluito. Con buona pace delle risorse pubbliche investite, dei proclami sull’istruzione e delle retoriche sul futuro.
Il futuro, come spesso accade, studia altrove.