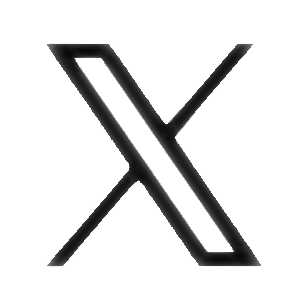Siamo solo all’inizio del 2026 e il mondo ha già mostrato la propria complessità in modo brutale e inequivocabile. Le crisi non si presentano più come eventi isolati, ma come sistemi intrecciati, in cui instabilità politica, competizione geopolitica, risorse energetiche e fragilità sociali si sovrappongono senza soluzione di continuità.
In questo scenario, la Libia non è un’eccezione, è una lente. Un luogo in cui le contraddizioni del nostro tempo si concentrano. Un Paese sospeso, non coinvolto in una guerra dichiarata, ma incapace di uscire davvero dal proprio dopo-guerra.
Sono passati quindici anni dal 20 ottobre 2011 e dalla caduta di Muammar Gheddafi, che per oltre quattro decenni aveva governato la Libia impedendone la frammentazione. La promessa di una transizione a beneficio del Paese si è invece trasformata in una lunga parentesi di instabilità, segnata da governi fragili, poteri concorrenti e una sovranità incompleta.
La Libia non è collassata, ma non si è mai ricomposta, vive in uno stato intermedio, un limbo in cui la politica non riesce a farsi Stato e la forza continua a sostituire la legittimità, come dimostra l’uccisione di Saif al-Islam Gheddafi, secondogenito di Muammar Ghedafi, morto, secondo fonti autorevoli della famiglia, al termine di duri scontri armati iniziati nel primo pomeriggio del 2 febbraio nell’area di al-Zintan.
Lo stesso, per lungo tempo è stato indicato come possibile successore del padre, nel 2021 aveva annunciato la propria candidatura alla presidenza, poi rinviata insieme alle elezioni. Non era più un protagonista centrale, ma restava una figura simbolica, ingombrante e ambigua. Per alcuni incarnava la possibilità di un ritorno a un ordine perduto per altri rappresentava ciò che non doveva più tornare.
La sua eliminazione non chiude una fase né apre automaticamente una nuova, è il segno di una Libia che continua a risolvere i nodi politici con strumenti extra-politici, perché manca uno spazio condiviso in cui il conflitto possa essere assorbito e trasformato. Il problema libico non è la presenza di troppe forze, ma l’assenza di un vero e solido centro di potere riconosciuto.
A Tripoli opera un governo formalmente legittimato dalla comunità internazionale, ma privo di un controllo effettivo sul territorio. A est, strutture politiche e militari autonome continuano a esercitare un potere reale, spesso più solido di quello istituzionale, in mezzo, si collocano una costellazione di milizie, alleanze locali e interessi economici che rende ogni equilibrio provvisorio e reversibile.
Nel marzo 2025 la National Oil Corporation, NOC, unica entità autorizzata alla vendita del petrolio libico e partner di compagnie internazionali come Eni, ha annunciato una scelta rilevante sul piano economico ed energetico, il primo vero licensing round dopo quasi due decenni, offrendo 22 blocchi esplorativi onshore e offshore nei bacini di Sirte, Murzuq e Ghadames, inattivi dal 2008. È una decisione che segna una più ampia liberalizzazione delle concessioni petrolifere e che dovrebbe entrare pienamente in vigore proprio in questo mese di febbraio 2026.
Si tratta di una scelta che nasce dalla necessità, non dalla forza. La Libia ha bisogno di liquidità, investimenti e partner in grado di rimettere in funzione infrastrutture logorate da anni di instabilità. La NOC, pur essendo formalmente l’azienda petrolifera di Stato, non vive dei proventi diretti dell’estrazione, questi confluiscono nelle casse centrali di Tripoli, che successivamente redistribuisce le risorse attraverso il bilancio statale. In un contesto istituzionale debole, in cui il controllo delle risorse resta frammentato e spesso mediato da rapporti di forza locali, il petrolio continua ad essere la principale ricchezza ma al tempo stesso il principale fattore di vulnerabilità del Paese.
Ogni giacimento, ogni terminal, ogni oleodotto è anche una leva politica. Liberalizzare le concessioni significa attrarre interessi internazionali, ma anche moltiplicare i punti di pressione su uno Stato che fatica a rialzarsi. Senza un’autorità centrale solida, l’economia energetica rischia di restare un terreno di competizione più che uno strumento di stabilizzazione.
A tutto questo si aggiunge la dimensione esterna, la Libia è un crocevia strategico per il Mediterraneo, per l’energia, per la sicurezza e i flussi migratori. Turchia, Russia, Paesi del Golfo, Egitto ed Europa continuano a muoversi nel Paese non come mediatori neutrali, ma come attori portatori di interessi propri. Ne deriva una stabilità apparente, sostenuta da forze armate e accordi tattici, più che da un reale processo politico inclusivo.
Sul piano umano e sociale, questa condizione prolungata di sospensione pesa in modo profondo. Le istituzioni civili restano deboli, i diritti diseguali, l’accesso ai servizi incerto, la migrazione, spesso gestita da attori non statali, è diventata un ulteriore spazio di potere, con conseguenze che oltrepassano i confini libici e investono l’intero Mediterraneo. La morte di Saif al-Islam Gheddafi, la liberalizzazione delle concessioni petrolifere e la persistente frammentazione del potere non sono eventi separati, sono sintomi di uno stesso problema, una transizione mai davvero governata.
Finché la Libia resterà priva di un patto politico capace di tenere insieme memoria, interessi e futuro, ogni scelta economica e ogni fatto di sangue continueranno a galleggiare in un sistema senza centro, non abbastanza instabile da crollare ma troppo fragile per reggersi in piedi davvero. Nel Mediterraneo allargato, e per l’Italia in particolare, questa fase libica non è uno scenario distante ma uno specchio strategico, ciò che accade sulle coste sud non resta mai confinato lì, ma definisce direttamente i confini reali della sicurezza, dell’energia e della responsabilità europea.