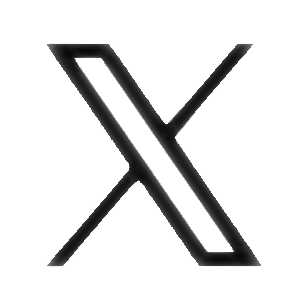di Giuseppe Gagliano*
Da oppositore a partecipante: il realismo di governo davanti al piano Trump per Gaza.
La decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aderire al Board of Peace voluto dal presidente statunitense Donald Trump segna una svolta più tattica che ideologica. Dopo le critiche iniziali alla composizione del comitato – giudicata non concordata e in contrasto con la linea israeliana, soprattutto per la presenza della Turchia – Netanyahu ha scelto di entrare nel meccanismo invece di subirlo dall’esterno. È una scelta di contenimento del rischio, non di adesione convinta a una visione.
Il Board of Peace era stato concepito come uno strumento limitato, incaricato di supervisionare il cessate il fuoco a Gaza. Nel giro di poche settimane, però, l’amministrazione Trump ne ha ampliato il perimetro, trasformandolo in un contenitore politico a vocazione globale, con l’ambizione dichiarata di mediare conflitti ben oltre il dossier palestinese. La stessa ipotesi che possa sostituire, o comunque marginalizzare, le Nazioni Unite non è stata esclusa da Trump, che continua a descrivere l’Onu come inefficace e incapace di esprimere il proprio potenziale.
Questa impostazione ha sollevato reazioni immediate in Europa. Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha chiarito che Parigi sostiene un piano di pace americano, ma non la creazione di una struttura alternativa che svuoti il ruolo dell’Onu. La freddezza del presidente Emmanuel Macron ha innescato la consueta risposta muscolare di Trump, arrivato a minacciare dazi punitivi sul vino francese.
Per Netanyahu, restare fuori dal Board avrebbe significato accettare che decisioni cruciali sul futuro di Gaza venissero prese senza una presenza israeliana diretta. La seconda fase del cessate il fuoco – la più delicata – prevede infatti il dispiegamento di una Forza di sicurezza internazionale, il ritiro delle truppe israeliane, il disarmo di Hamas e la ricostruzione del territorio sotto una gestione palestinese tecnocratica supervisionata dall’esterno. Tutti elementi che l’attuale governo israeliano guarda con sospetto, quando non con aperta ostilità.
Entrare nel Board significa quindi cercare di condizionarne l’agenda dall’interno, limitando gli spazi di manovra di attori considerati ostili o concorrenti, come Ankara e Doha, che Israele ha già tentato di escludere da qualsiasi forza di stabilizzazione.
La scelta di Netanyahu rischia però di acuire le tensioni nella sua coalizione. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, espressione dell’ala più radicale della destra israeliana, ha criticato apertamente il Board, chiedendo che Israele si assuma in modo unilaterale la responsabilità del futuro di Gaza. Per questa componente politica, qualsiasi coinvolgimento internazionale rappresenta un cedimento strategico e simbolico.
La composizione del Board riflette un’impostazione non convenzionale. Vi partecipano Paesi tra loro molto diversi, dagli Emirati Arabi Uniti al Marocco, dall’Ungheria alla Bielorussia, fino all’Argentina e al Vietnam. Altri Stati – tra cui Regno Unito, Canada, Egitto, Russia e Turchia – hanno ricevuto inviti ma non hanno ancora formalizzato l’adesione. La struttura interna assegna un potere quasi assoluto al presidente statunitense, che nomina e revoca i membri, decide quando e su cosa il Board si riunisce e può adottare risoluzioni di propria iniziativa.
Secondo l’analisi del Guardian, il Board rappresenta un classico caso di “esca e scambio”: approvato inizialmente dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu come strumento per Gaza, si è progressivamente trasformato in un organismo permanente che ambisce a sostituire le agenzie internazionali tradizionali con meccanismi più opachi e, in parte, orientati al profitto.
L’adesione di Netanyahu al Board of Peace non va letta come una legittimazione piena del progetto trumpiano, ma come una mossa difensiva. In un contesto in cui l’architettura della governance internazionale viene messa in discussione dagli Stati Uniti stessi, Israele ha scelto di non restare spettatore. Entrare nel Board significa accettare un terreno di gioco instabile, ma anche evitare che altri decidano, da soli, sul futuro di Gaza e sugli equilibri regionali. È il realismo del potere: meglio sedersi a un tavolo imperfetto che rischiare di trovarsi di fronte a decisioni già prese.
*in collaborazione multimediale con Notizie Geopolitiche