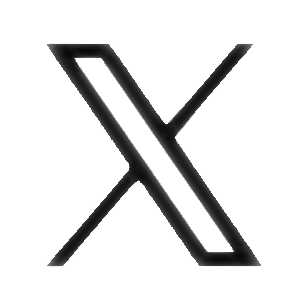di Giuseppe Lai*
Le conferenze sul clima e l’asimmetria tra interessi nazionali e multilateralismo
I casi di Cina e Usa
Il 21 novembre si è conclusa in Brasile la COP 30, l’edizione 2025 della Conferenza delle Parti (COP), il più grande evento globale per le discussioni e i negoziati sui cambiamenti climatici. Tenutasi a Belem, una delle porte di accesso all’Amazzonia, la Conferenza celebra i dieci anni dagli Accordi di Parigi del 2015 (COP 21), che avevano orientato politiche, investimenti e sistemi di monitoraggio delle emissioni inquinanti definendo un quadro di riferimento per la gestione dei cambiamenti climatici. Una tappa storica, che tuttavia a distanza di un decennio lascia sostanzialmente immutate le criticità e le problematiche inerenti la “governance” delle emissioni climalteranti, che continuano a crescere anche se meno rapidamente rispetto al passato. In pratica, la consapevolezza globale di una sfida che interessa l’intero pianeta non si è tradotta in azioni concrete e condivise da parte di tutti gli attori in gioco, statali e non statali, aumentando le distanze rispetto a un “multilateralismo” climatico che avrebbe condotto a esiti più incoraggianti in termini di riduzione delle emissioni.
I dati più recenti indicano il 2024 l’anno più caldo degli ultimi 175 anni: la temperatura globale ha raggiunto +1,55°C sopra i livelli preindustriali. E’ stata superata proprio quella soglia di 1,5°C che dieci anni fa i 196 Paesi che firmarono l’Accordo di Parigi avevano concordato di non oltrepassare. Il prezzo da pagare era l’incremento di eventi estremi come inondazioni, siccità prolungata, desertificazione, di cui da tempo si avvertono gli impatti devastanti, in linea con le proiezioni dei modelli matematici. Sebbene sia doveroso precisare che un singolo anno (2024) sopra la soglia non vanifica gli sforzi fatti finora, dal momento che l’evoluzione climatica si valuta su un periodo di 20-30 anni, la situazione attuale non appare promettente.
Nel 2015 il target di temperatura globale si attestava su +3,8°C entro il 2100, oggi le stime convergono su +2,5–2,9°C entro la fine del secolo. Un risultato modesto, offuscato dalle proiezioni dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, il quale indica una probabilità superiore al 50% che il riscaldamento globale superi 1,5°C tra il 2021 e il 2040. Ragionare sulle cause che hanno determinato queste dinamiche implica la valutazione di una molteplicità di fattori. Tra questi, quello che può essere definito il denominatore comune delle COP sul clima susseguitesi negli anni è la difficoltà di raggiungere un compromesso tra gli interessi economici e geopolitici dei singoli Stati e la necessità di agire in tempi rapidi per contenere il climate change. E’ vero che nel decennio 2015-2025 la transizione energetica ha compiuto notevoli passi in avanti. Produrre energia con gli impianti solari costa oggi quasi il 60% in meno rispetto al 2015 e nel 2024, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, le fonti rinnovabili hanno coperto oltre il 30% della produzione elettrica mondiale. Ma c’è un numero in controtendenza che svuota di significato questi dati: nel 2024 le emissioni globali sono aumentate dell’1,3% rispetto al 2023, un nuovo massimo storico. In altri termini, si costruiscono più impianti “green”, ma si continua ad emettere più CO2 di prima. E come se la crescita delle rinnovabili affiancasse quella dei combustibili fossili anziché sostituirla.
L’emblema di tale paradosso è la Cina, che con il 27% delle emissioni globali è il primo emettitore mondiale di CO2 e al tempo stesso il motore principale della transizione energetica. Nel 2024 il Dragone, da un lato ha installato oltre il 50% della nuova capacità solare ed eolica globale, dall’altro, negli ultimi due anni ha autorizzato la costruzione di nuove centrali a carbone, che oggi rappresentano il 56% del suo mix energetico. In realtà se si guarda al fabbisogno energetico cinese, il paradosso è solo apparente: l’economia cresce, la domanda di energia decolla e le rinnovabili, pur crescendo a ritmi impressionanti, non riescono ancora a soddisfarla completamente. La fonte più rapida e economica per colmare il divario resta il carbone, che ha alimentato lo sviluppo del Paese negli ultimi trent’anni. La lettura più immediata che emerge da questi dati è che l’investimento in rinnovabili risponde più ad interessi economici che ad obbiettivi concreti di salvaguardia del pianeta.
Sotto quest’ultimo aspetto, i due target annunciati dal governo cinese, picco delle emissioni prima del 2030 e neutralità carbonica entro il 2060, dovrebbero avere piena attuazione, considerando che senza la Cina non c’è soluzione alla crisi climatica.
Dal lato occidentale, gli Stati Uniti di Donald Trump sono usciti dagli Accordi di Parigi, privilegiando l’industria dei combustibili fossili da cui provengono molti generosi donatori della campagna elettorale del Tycoon. È l’America del “Drill, baby, drill”, delle trivellazioni petrolifere ovunque, nel segno di una politica antigreen e dichiaratamente antiscientifica. Ciò è reso evidente dalla scelta dell’amministrazione americana di oscurare i siti ufficiali che riportavano le valutazioni nazionali sul clima, studi scientifici che documentavano in maniera chiara e rigorosa gli impatti del riscaldamento globale negli Stati Uniti. Considerando le proiezioni dei modelli matematici sempre più affidabili, tale atteggiamento configura, tra l’altro, un potenziale autogol. Quei documenti, infatti, non erano semplici analisi: rappresentavano strumenti concreti a disposizione di governi e comunità locali per pianificare strategie di adattamento e tutelare infrastrutture, sistemi sanitari ed economie dalle conseguenze del clima che cambia. Ma l’America continua ad alimentare il sogno americano con carbone e petrolio e, al tempo stesso, le proprie emissioni inquinanti, che nel 2025 sono previste in aumento dell’1.9%.
I due casi, cinese e americano, pur nella diversità dei rispettivi sistemi statali e delle dinamiche politico-economiche al loro interno, hanno un approccio comune rispetto alla sfida climatica: privilegiare l’interesse nazionale. Ciò è conseguenza evidente della crisi del multilateralismo, legata a vari fattori di ordine politico ed economico come il peso crescente dei nazionalismi, le competizioni tra le grandi potenze per il controllo delle tecnologie verdi e delle risorse minerarie (indispensabili per la transizione energetica) i conflitti in corso, da quello ucraino alle tensioni in Medio Oriente. Un quadro siffatto ostacola la possibilità di raggiungere accordi significativi tra i vari Paesi e di costruire un coordinamento condiviso su temi cruciali come il cambiamento climatico. Eppure, il multilateralismo è il fondamento su cui si basa la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), un principio che non è emerso completamente da un piano strettamente concettuale proprio per le criticità prima citate. A queste si aggiungono alcune clausole contenute negli Accordi di Parigi che costituiscono un limite alla sua efficace applicazione. Esse prevedono, ad esempio, che ogni Stato definisca e aggiorni periodicamente i propri obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso i Contributi Nazionali Determinati (NDC). L’obbligo tuttavia riguarda la presentazione degli NDC, che ogni Stato calibra sulle proprie capacità economiche, ma essi non sono giuridicamente vincolanti: ogni Paese decide autonomamente il target di emissioni e non esistono sanzioni in caso di mancato rispetto. Gli stessi Accordi prevedono che i Paesi più avanzati forniscano supporto tecnico e finanziario a quelli più vulnerabili, per favorire sia la transizione energetica sia la resilienza climatica. In realtà l’allocazione dei finanziamenti spesso favorisce le stesse economie avanzate, con un flusso limitato verso i Paesi in via di sviluppo. Questo tende a rallentare l’adozione di misure incisive a livello globale, come evidenziato dal basso livello di investimenti in Africa, che riceve solo una minima parte dei fondi climatici globali nonostante sia una delle regioni più colpite dagli effetti del climate change. La COP 30 si è conclusa con la ormai convenzionale dichiarazione di intenti, lasciando irrisolti i nodi centrali dell’azione climatica: l’uscita equa, giusta e ordinata dai combustibili fossili, l’inversione della deforestazione, gli impegni concreti per la finanza climatica, l’osservanza dei vincoli sottoscritti. Un copione che si ripete da troppi anni.
*in collaborazione multimediale con Notizie Geopolitiche