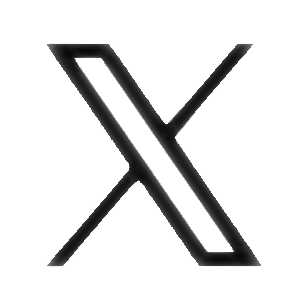Netanyahu all’ONU: tra Isratine, “lavoro sporco” e la verità scomoda delle due Palestine
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è da sempre il palcoscenico in cui leader politici cercano non solo di rivolgersi al mondo, ma anche di scolpire la propria immagine nella storia. Per alcuni, come Nelson Mandela o Václav Havel, è stato lo spazio della legittimazione internazionale. Per altri, da Fidel Castro a Hugo Chávez, è stato il pulpito dell’invettiva. Benjamin Netanyahu, da anni abituato a muoversi tra mappe, moniti e frasi ad effetto, ha fatto della tribuna ONU il suo teatro preferito.
Anche quest’anno, il premier israeliano ha scelto di affrontare un’aula semivuota: molte delegazioni hanno abbandonato la sala in segno di protesta, lasciando un’immagine simbolica di isolamento. Ma per Netanyahu, quell’assenza è servita più di una presenza: il suo discorso era rivolto meno ai delegati e più all’opinione pubblica mondiale e, soprattutto, agli alleati che Israele non può permettersi di perdere.
Il contenuto del discorso, al di là delle frasi già note e dei toni taglienti, riflette una strategia precisa: costruire una narrativa globale in cui Israele non è il problema, bensì la soluzione. Non il nemico del Medio Oriente, ma il suo indispensabile baluardo.
Dietro la retorica e i richiami alla sicurezza, il punto centrale resta irrisolto: che cosa si riconosce, esattamente, quando la comunità internazionale proclama l’esistenza di uno Stato palestinese?
Il quesito non è teorico, ma pratico. Se si riconosce uno Stato unico che comprende Cisgiordania e Gaza, si finge di ignorare che l’Autorità Palestinese non riconosce ad Hamas alcun ruolo politico, e che lo stesso Qatar — pur considerato mediatore privilegiato — non è disposto a legittimare Hamas come attore statale. Gaza e Cisgiordania sono due entità politiche e militari separate, divise da rivalità profonde e dalla memoria di scontri sanguinosi.
D’altra parte, se si riconoscono due entità distinte — una a Gaza, una in Cisgiordania — si accetta implicitamente l’idea di due “Palestine” rivali. Ma a quel punto, cosa accadrà il giorno in cui inevitabilmente verranno alle armi? La comunità internazionale manderà una delegazione di celebrità, influencer o attivisti “green” a recitare un sermone sulla pace?
Il rischio è che l’indignazione diventi pura retorica, una valvola di sfogo emotivo che non incide minimamente sulla realtà. La politica internazionale, invece, richiederebbe lucidità, pragmatismo e — soprattutto — il coraggio di affrontare domande scomode senza rifugiarsi nelle soluzioni simboliche.
In questo contesto torna d’attualità un’idea bizzarra e visionaria proposta da Mu’ammar Gheddafi nel 2009: la creazione di “Isratine”, uno Stato unico binazionale in cui israeliani e palestinesi avrebbero condiviso istituzioni e sovranità.
All’epoca, la proposta del leader libico venne accolta con sarcasmo e sospetto: per i governi occidentali era l’ennesima provocazione di un dittatore eccentrico; per Israele, un incubo demografico; per i palestinesi, una resa camuffata. Eppure, come sottolinea OFCS, oggi quella visione appare quasi profetica.
Non tanto perché sia realizzabile — anzi, resta politicamente impraticabile — ma perché rivela la fragilità delle altre opzioni. Uno Stato palestinese senza unità interna è un guscio vuoto. Due Stati contrapposti sono una ricetta per la guerra civile. Una “Isratine” binazionale è un’utopia, ma almeno non è un autoinganno.
Netanyahu, ovviamente, respinge con forza ogni ipotesi del genere: per lui, uno Stato palestinese è una minaccia esistenziale, figuriamoci uno Stato misto. Eppure, il solo fatto che l’ombra di Gheddafi ritorni nelle analisi dimostra quanto la situazione sia intrappolata in una spirale di contraddizioni irrisolte.
Un altro punto di vista, espresso sulle colonne del Nuovo Giornale Nazionale, rovescia il giudizio morale sulla condotta di Netanyahu. Secondo questa lettura, il premier israeliano non è soltanto il difensore di Israele, ma colui che compie il “lavoro sporco” per conto dell’Occidente.
Israele, insomma, non si batte solo per se stesso. Con le sue operazioni militari, con il suo linguaggio duro e con la sua intransigenza, fa ciò che altri Paesi non possono permettersi di fare apertamente: contenere l’Iran, indebolire Hezbollah, interrompere i traffici degli Houthi nello Yemen, mantenere la stabilità energetica del Mediterraneo.
In questa chiave, il discorso all’ONU assume un significato diverso. Non si tratta di un leader assediato che cerca giustificazioni, ma di un attore consapevole che ricorda al mondo quanto dipenda da Israele. Un messaggio tanto brutale quanto efficace: “Ci condannate di giorno, ma ci affidate la notte.”
Pochi giorni prima dell’intervento ufficiale, circolava un discorso “fittizio” di Netanyahu, un esercizio retorico che elencava con toni trionfali i successi di Israele: la distruzione di Hamas, i colpi inflitti a Hezbollah, la paralisi del programma nucleare iraniano, le alleanze regionali rafforzate, i progressi tecnologici e militari.
Riletto oggi, quel testo sembra quasi un copione che Netanyahu ha in parte recitato davvero. Frasi come “Israele non è il nemico: è l’incubo dei suoi avversari e l’assicurazione sulla vita dei suoi partner” riecheggiano nel discorso reale.
Questo parallelismo non è casuale: dimostra quanto la narrativa israeliana sia ormai consolidata, prevedibile e ripetuta, ma anche quanto sia efficace. Israele ha imparato a costruire un racconto che resiste alle condanne e sopravvive alle crisi.
Il punto debole di questo racconto, tuttavia, è rappresentato dalla situazione umanitaria a Gaza. Le immagini di città rase al suolo, i numeri di vittime civili, le accuse di genocidio: tutto questo contrasta con la narrativa della “difesa necessaria” e mina la credibilità di Israele presso ampie fasce dell’opinione pubblica mondiale.
Netanyahu liquida le accuse come menzogne. Ma la discrepanza tra racconto e realtà è una crepa che rischia di allargarsi. Ed è qui che si gioca la partita più pericolosa: se Israele perde il sostegno morale dell’Occidente, la sua funzione di scudo diventa politicamente insostenibile, per quanto militarmente solida possa restare.
Uno dei passaggi più duri del discorso fittizio — e riecheggiato in quello reale — riguarda l’Europa: “Ci condannate pubblicamente, ma dipendete da nostra tecnologia, dal nostro gas, dalla nostra intelligence.”
Difficile smentire questo dato di fatto. L’Europa si trova stretta in una contraddizione permanente: da un lato, governi e opinioni pubbliche chiedono dure prese di posizione contro Israele; dall’altro, gli stessi governi sanno che Israele è indispensabile per l’energia del Mediterraneo, per le tecnologie di difesa, per la sicurezza informatica.
È un’ipocrisia strutturale, che Netanyahu sfrutta abilmente. Sa che le condanne non hanno conseguenze concrete, e che nei tavoli riservati le collaborazioni continuano indisturbate.
Lo stesso vale per gli alleati arabi: Egitto, Giordania, Emirati, persino l’Arabia Saudita. Tutti criticano Israele a parole, tutti devono rispondere alle proprie opinioni pubbliche. Ma nel frattempo, tutti sanno che senza Israele la pressione dell’Iran e dei Fratelli Musulmani diventerebbe insostenibile.
Così, Netanyahu costruisce una diplomazia parallela, fatta di incontri segreti, canali militari, intese energetiche. Una rete che non compare nelle cronache ufficiali, ma che regge l’architettura di sicurezza della regione.
Alla fine, la domanda resta sospesa, irrisolta e forse irrisolvibile: quale Palestina vuole riconoscere il mondo?
Una Palestina unica? Significa integrare Hamas, cosa che nessuno è disposto a fare.
Due Palestine separate? Significa istituzionalizzare la divisione e preparare il terreno a un conflitto interno.
Una Isratine binazionale? Significa affrontare la questione demografica e identitaria, cioè la più esplosiva di tutte.
Per ora, l’Occidente preferisce non rispondere. Netanyahu, invece, preferisce che la domanda resti aperta: perché ogni risposta rischia di essere più pericolosa della guerra stessa.
Il discorso di Netanyahu all’ONU, reale o fittizio, mette il mondo davanti a un paradosso. Indignarsi è facile. Costruire soluzioni è quasi impossibile.
Riconoscere la Palestina senza chiarire cosa si stia riconoscendo è un gesto vuoto. Criticare Israele senza riconoscere il suo ruolo come baluardo regionale è ipocrita. Illudersi che slogan e sermoni possano sostituire la politica è pura ingenuità.
Forse Gheddafi, con la sua bizzarra “Isratine”, aveva colto meglio di altri il vicolo cieco in cui ci troviamo. Forse Netanyahu, con il suo ruolo di “esecutore del lavoro sporco”, esprime una verità che nessuno vuole ammettere apertamente.
L’unica certezza è che la crisi non si risolverà con un riconoscimento formale, ma con il coraggio politico — oggi assente — di affrontare il nodo centrale: quale Palestina, e quale Israele, possono davvero coesistere?
Fonti e approfondimenti
- OFCS – Netanyahu, Isratine e la lungimiranza di Gheddafi
- Nuovo Giornale Nazionale – Netanyahu sta solo facendo il lavoro sporco
Netanyahu at the UN: between Isratine, “dirty work,” and the inconvenient truth of the two Palestines
The United Nations General Assembly has always been the stage where political leaders seek not only to address the world but also to carve their own image in history. For some, like Nelson Mandela or Václav Havel, it has been the space of international legitimacy. For others, from Fidel Castro to Hugo Chávez, it has been the pulpit of invective. Benjamin Netanyahu, for years accustomed to moving between maps, warnings and catchphrases, has made the UN forum his favorite theater.
Once again this year, the Israeli premier chose to face a half-empty hall: many delegations left the room in protest, leaving a symbolic image of isolation. But for Netanyahu, that absence served more than a presence: his speech was aimed less at delegates and more at world opinion and, above all, at the allies Israel cannot afford to lose.
The content of the speech, beyond the familiar phrases and sharp tones, reflects a precise strategy: to construct a global narrative in which Israel is not the problem but the solution. Not the enemy of the Middle East, but its indispensable bulwark.
Behind the rhetoric and calls for security, the central point remains unresolved: what exactly is recognized when the international community proclaims the existence of a Palestinian state?
The question is not theoretical, but practical. If one recognizes a single state encompassing the West Bank and Gaza, one pretends to ignore the fact that the Palestinian Authority does not recognize Hamas as having any political role, and that Qatar itself - while considered a privileged mediator - is unwilling to legitimize Hamas as a state actor. Gaza and the West Bank are two separate political and military entities, divided by deep-seated rivalries and the memory of bloody clashes.
On the other hand, if you recognize two separate entities-one in Gaza, one in the West Bank-you implicitly accept the idea of two rival "Palestines." But at that point, what will happen the day they inevitably come to arms? Will the international community send a delegation of celebrities, influencers or "green" activists to deliver a sermon on peace?
The risk is that outrage will become pure rhetoric, an emotional release valve that does not affect reality in the slightest. International politics, on the other hand, would require lucidity, pragmatism and - above all - the courage to address uncomfortable questions without taking refuge in symbolic solutions.
In this context, a bizarre and visionary idea proposed by Mu'ammar Gaddafi in 2009 comes back to the fore: the creation of "Isratine," a single binational state in which Israelis and Palestinians would share institutions and sovereignty.
At the time, the Libyan leader's proposal was greeted with sarcasm and suspicion: for Western governments, it was yet another provocation by an eccentric dictator; for Israel, a demographic nightmare; for the Palestinians, a disguised surrender. Yet, as OFCS points out, today that vision seems almost prophetic.
Not so much because it is achievable - indeed, it remains politically impractical - but because it reveals the fragility of the other options. A Palestinian state without internal unity is an empty shell. Two opposing states is a recipe for civil war. A binational "Isratine" is a utopia, but at least it is not self-deception.
Netanyahu, of course, strongly rejects any such hypothesis: for him, a Palestinian state is an existential threat, let alone a mixed state. Yet the mere fact that the shadow of Qaddafi returns in the analyses shows how trapped the situation is in a spiral of unresolved contradictions.
Another viewpoint, expressed in the columns of the New National Newspaper, reverses the moral judgment on Netanyahu's conduct. According to this reading, the Israeli premier is not only the defender of Israel, but the one who does the "dirty work" on behalf of the West.
Israel, in short, is not just fighting for itself. With its military operations, with its tough language and intransigence, it does what other countries cannot afford to do openly: contain Iran, weaken Hezbollah, disrupt Houthi trafficking in Yemen, maintain the energy stability of the Mediterranean.
In this key, the speech at the UN takes on a different meaning. This is not a beleaguered leader seeking justification, but a conscious actor reminding the world how dependent it is on Israel. A message as brutal as it is effective: "You condemn us by day, but you entrust us by night."
A few days before the official intervention, a "fictitious" speech by Netanyahu circulated, a rhetorical exercise listing in triumphant tones Israel's successes: the destruction of Hamas, the blows inflicted on Hezbollah, the paralysis of Iran's nuclear program, strengthened regional alliances, and technological and military advances.
Reread today, that text almost sounds like a script that Netanyahu has in part actually recited. Phrases like "Israel is not the enemy: it is the nightmare of its adversaries and the life insurance of its partners" echo in the actual speech.
This parallelism is not accidental: it shows how well-established, predictable and repeated the Israeli narrative is, but also how effective it is. Israel has learned to construct a narrative that resists condemnation and survives crises.
The weak point in this narrative, however, is the humanitarian situation in Gaza. The images of cities razed to the ground, the numbers of civilian casualties, the accusations of genocide-all of these contrast with the "necessary defense" narrative and undermine Israel's credibility with large swaths of world opinion.
Netanyahu dismisses the accusations as lies. But the discrepancy between narrative and reality is a crack that threatens to widen. And this is where the most dangerous game is played: if Israel loses the moral support of the West, its shield function becomes politically untenable, however militarily robust it may remain.
One of the harshest passages in the fictional speech - and echoed in the real one - concerns Europe: "You publicly condemn us, but you depend on our technology, our gas, our intelligence."
This fact is hard to disprove. Europe is caught in a permanent contradiction: on the one hand, governments and public opinion call for tough stances against Israel; on the other hand, the same governments know that Israel is indispensable for Mediterranean energy, for defense technologies, for cybersecurity.
It is a structural hypocrisy, which Netanyahu skillfully exploits. He knows that condemnations have no real consequences, and that at confidential tables collaborations continue undisturbed.
The same goes for Arab allies-Egypt, Jordan, the Emirates, even Saudi Arabia. Everyone criticizes Israel in words, everyone has to answer to their public opinions. But meanwhile, everyone knows that without Israel, the pressure from Iran and the Muslim Brotherhood would become untenable.
Thus, Netanyahu builds a parallel diplomacy of secret meetings, military channels, energy arrangements. A network that does not appear in the official news, but which holds up the region's security architecture.
In the end, the question remains suspended, unresolved and perhaps unsolvable: which Palestine does the world want to recognize?
A unique Palestine? It means integrating Hamas, which no one is willing to do.
Two separate Palestines? It means institutionalizing the division and preparing the ground for internal conflict.
A binational Isratine? It means addressing the demographic and identity issue, that is the most explosive of all.
For now, the West prefers not to respond. Netanyahu, on the other hand, prefers to keep the question open: because any answer risks being more dangerous than the war itself.
Netanyahu's speech to the UN, real or fictitious, confronts the world with a paradox. To be outraged is easy. Building solutions is almost impossible.
Recognizing Palestine without clarifying what is being recognized is an empty gesture. To criticize Israel without acknowledging its role as a regional bulwark is hypocritical. To delude oneself that slogans and sermons can replace politics is pure naiveté.
Perhaps Qaddafi, with his bizarre "Isratine," had grasped better than others the dead end we find ourselves in. Perhaps Netanyahu, with his role as "doer of the dirty work," expresses a truth that no one wants to openly admit.
The only certainty is that the crisis will not be resolved with formal recognition, but with the political courage-absent today-to address the central issue: which Palestine, and which Israel, can really coexist?