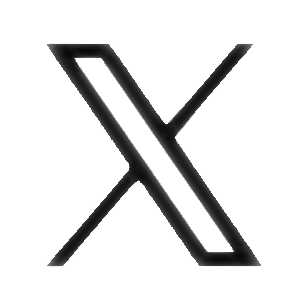di Aldo A. Mola
Stati in cerca di pace?
Spirava un placido zefiro sull'Europa all'inizio del 1926. Era lo “spirito di Locarno”, la gradevole città svizzera ove nell'ottobre precedente erano stati messi a punto gli Accordi che posero fine alle logoranti dispute lasciate alle spalle dai tanti Trattati di pace postbellici. A fare la prima mossa era stata la Germania. Il 20 gennaio 1925 essa propose alla Gran Bretagna una conferenza per dare corpo al Protocollo di Ginevra (2 ottobre 1924) e regolare pacificamente le controversie internazionali, come auspicato dalla Società delle Nazioni, nata con la Pace di Versailles del 28 giugno 1919.
Per due anni gli Stati Uniti d'America erano stati protagonisti della storia mondiale con i quattordici punti enunciati dal presidente Wilson l'8 gennaio 1918. I Trattati di Versailles, Saint-Germain, Neully, Trianon e Sèvres avevano anche formalmente inglobato la “dottrina Monroe” del dicembre 1823 (“l'America agli Americani”) quale pilastro portante della pace universale. Poi, però, Washington non aveva ratificato l'adesione alla Società delle Nazioni e gli Usa erano tornati al neo-isolazionismo.
Pertanto l'Europa decise di fare da sé, grazie a politici meno rancorosi di quelli (come il francese Clemenceau, detto “il Tigre”) che avevano trasformato il congresso di Versailles nell'umiliazione dei popoli vinti, condannati a riparazioni economiche rovinose quali “responsabili morali” della guerra. La Francia, con Artistide Briand, la Germania “di Weimar”, con Gustav Stresemann, e la Gran Bretagna, con Austen Chamberlain, affiancati dal belga Vandervelde e dall'italiano Vittorio Scialoja, a nome dei rispettivi capi di Stato concordarono una sorta di pace perpetua. Aderirono Belgio, Polonia, Cecoslovacchia e l'Italia di Benito Mussolini.
La Società delle Nazioni, che aveva sede a Ginevra, non lungi da Locarno, formalmente risultò assente, ma alle trattative partecipò e all'Accordo finale aderì un nucleo di “volonterosi”, cioè gli Stati che avevano speso maggiori risorse e vite umane nella guerra e avvertivano più forte il bisogno di mettersi alle spalle il “revisionismo”, cioè le contese per minuscole rettifiche di frontiera dalle motivazioni spesso fragili. L'Italia, per esempio, visse quasi due anni il dramma della rivendicazione di Fiume: un episodio minore rispetto ai conflitti in atto o latenti tra gli Stati sorti dalle rovine degli imperi germanico, austro-ungarico e zarista e a fronte della nascita del regno serbo-croato-sloveno. L'Albania, che l'Italia considerava sua naturale area di espansione, faceva gola anche alla Francia, in funzione pro-jugoslava e nettamente anti-italiana. Gli egoismi degli Stati sovrani continuavano dunque ad avere la meglio sulla proposta di una federazione europea, prospettata con lungimiranza da Luigi Einaudi e da personalità pragmatiche come Giovanni Agnelli e Attilio Cabiati.
La pace tra gli Stati era necessaria ai governi per propiziare la stabilità all'interno di ciascuno dei contendenti. A Locarno Gran Bretagna e Italia vennero riconosciuti garanti dei patti. Fra gli statisti più impegnati nel perseguimento degli accordi ivi assunti ben tre (Briand, Stresemann e Chamberlain) meritarono l'ambito Premio Nobel per la Pace: un riconoscimento non conferito ad alcuno nel corso della Grande Guerra, né nel 1923 e 1924. Due tra gli Stati contraenti di maggior rilievo, Francia e Inghilterra, erano alle prese con l'amministrazione fiduciaria delle colonie sottratte alla Germania e con la gestione degli immensi “spazi” politici ed etnici (alcuni con sovrani “fantoccio”) sorti dalla deflagrazione dell'impero ottomano, ridotto alla sola Anatolia e alla “Turchia europea”, come poi ribadì la pace di Losanna del 1923.
Il vento di Locarno continuò a spirare. Il 28 agosto 1928 Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Giappone, Polonia e Cecoslovacchia sottoscrissero a Parigi un Trattato generale di rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale. A nome dei loro popoli le Alte Parti condannarono il ricorso alla guerra per il regolamento di controversie internazionali. Il Trattato rimase aperto all'adesione di quanti non fossero tra i suoi firmatari originali. Di seguito, una serie di conferenze avrebbe stabilito i rapporti tra il tonnellaggio delle navi da guerra dei maggiori Stati e altre clausole per il controllo degli armamenti. Nel giugno-luglio 1933 le Quattro grandi potenze (Gran Bretagna, Francia, Italia e Germania, che tornò a figurarvi al posto degli USA, alle prese con la Grande depressione e con le misure per superarla: il “new deal” di Franklin D. Roosevelt) sottoscrissero il “Patto Mussolini” fondato sulla convinzione che il disagio regnante nel mondo andava superato con la reciproca solidarietà, fondamento della pace. Per la Germania firmò Ulrich von Hassel.
Venti tempestosi: Nazismo e Terza Internazionale
Ma a quel punto allo zefiro di Locarno era subentrato l'uragano: la vittoria elettorale del partito nazionalsocialista dei lavoratori, o “nazista”, guidato da Adolf Hitler. Al potere da pochi mesi in Germania questi dapprima dette vita con Gran Bretagna, Francia e Italia al “patto a quattro” per la revisione dei trattati, ma poco dopo disdisse l'adesione alla Società delle Nazioni e uscì dalla conferenza sul disarmo. Ogni Stato si arroccò sui propri obiettivi politici e, conseguentemente, militari, in lotta serrata contro gli altri. Ovunque la produzione bellica registrò un'impennata. La fiducia nei mezzi diplomatici per la risoluzione dei conflitti precipitò vicino allo zero.
Negli anni immediatamente postbellici si registrò in Asia la pullulazione di partiti comunisti aderenti la Terza Internazionale di Mosca. Avevano dimensioni minuscole. Ponevano problemi di polizia. Ma il loro ruolo dipendeva dalla conclusione del conflitto in corso all'interno del Partito comunista sovietico. Da problema di polizia in breve potevano mutarsi in organizzazioni di guerriglieri.
L'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche era stata il grande assente al Trattato di Locarno. Aveva altre priorità. A Mosca nel 1926 si stava avviando alla fase finale la lotta fra chi, come Lev Trotzky, mirava a esportare la rivoluzione nell'Europa centro-occidentale, che aveva una classe operaia strutturata da decenni, per poi farla rimbalzare nei continenti extraeuropei, collegandola con quella la contro il dominio coloniale europeo e l'imperialismo statunitense, e chi invece, come Stalin, puntava alla realizzazione del socialismo nell'unico Paese, la Russia, nel quale era giunto faticosamente al potere e doveva radicarsi combattendo spietatamente ogni opposizione interna e internazionale.
Per Benito Mussolini la vittoria di Stalin nell'ambito della Terza Internazionale fu una benedizione. Per lui voleva dire mani avere libere contro l'unico oppositore davvero temibile: il partito comunista d'Italia, che, in caso diverso, avrebbe contato su appoggi illimitati e nettamente opposti allo “spirito di Locarno”. Fu la conclusione alla quale approdò il congresso del partito comunista d'Italia che si svolse a Lione nel gennaio 1926 con la partecipazione di Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti. Gramsci vi ottenne l'approvazione della sua “tesi”: la saldatura tra gli operai dell'Italia settentrionale e i contadini diseredati di quella meridionale contro il regime fascista, il “nemico di classe”, espressione della borghesia che sommava potere finanziario ed espansione industriale, fiancheggiata dalla monarchia e dalla chiesa cattolica. Quella “lotta” avrebbe richiesto tempi lunghi ma, nella visione gramsciana, non contemplava altri protagonisti. Liberal-democratici (come Giolitti), demo-sociali (Colonna di Cesarò), socialisti di varia denominazione (Turati), democratici (Bonomi), repubblicani più o meno intransigenti (Eugenio Chiesa, Cipriano Facchinetti) e popolari (De Gasperi) erano nient'altro che comparse residuali a fronte del duello mortale tra comunismo e fascismo, tra la Terza internazionale e il suo nemico, la borghesia, forte di alleati e di succubi, come i socialdemocratici, di lì a poco bollati da Mosca come social-fascisti.
Come Mussolini faceva anche cose buone...
Nel corso del 1926 Mussolini mirò in Italia alla realizzazione di obiettivi economici e sociali atti ad attirare il consenso di ampie masse della media e piccola borghesia e dei ceti operai, sempre dell'ambito della cornice di relazioni internazionali che ne rafforzarono l'immagine di politico duttile e concludente. In tale direzione conseguì due importanti successi. A fine gennaio la Gran Bretagna ridusse il debito di guerra dell'Italia da 600 a soli 200 milioni e ne concesse la restituzione rateale entro il 1988. Analogamente Roma stipulò con Washington la restituzione dell'ingente prestito di guerra in rate semestrali per la durata di sessant'anni (fino al 1987). È appena il caso di ricordare che nel 1940-1941, con gesto poco apprezzato dai creditori, il “Duce” volle la guerra contro la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America.
Il 18 agosto 1926 Mussolini pronunciò a Pesaro un roboante discorso in difesa della lira fissandone il cambio con la sterlina a quota 92 (dalla propaganda arrotondata a “quota 90”): un'operazione sgradita agli industriali, alle prese con difficoltà nell’importazione di materie prime e nell'esportazione dei loro prodotti. Essi vennero ammansiti con la reiterata riduzione unilaterale dei salari, imposta alle maestranze in nome della difesa dell'economia nazionale e con la lotta governativa contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo.
Assunto personalmente il ministero delle Corporazioni, istituito il 2 luglio 1926, con sottosegretari Giacomo Suardo e Giuseppe Bottai, già iniziato massone nella loggia “La Forgia “ di Roma (aderente alla Gran Loggia d'Italia), Mussolini moltiplicò le iniziative “nell'interesse fisico e morale della razza”, come poi osservò Giorgio Alberto Chiurco in “La Rivoluzione fascista” (vol. V, p. 427). A tale scopo riciclò il filosofo tedesco Hegel («non è uomo chi non è padre») e nella rivista“Gerarchia” ammonì: «in un'Italia tutta bonificata, coltivata, irrigata, disciplinata, cioè fascista, c'è posto e pane ancora per 10 milioni di uomini. Sessanta milioni di italiani faranno sentire il peso della loro massa e della loro forza nella storia del mondo.» Per incrementare le nascite impose la tassa sui celibi maggiori di 25 anni e ridusse le imposte ai padri di almeno 7 figli.
La battaglia demografica fu assecondata con la “Vittoria del grano” come inizialmente venne detta la celebre “Battaglia del grano”. Essa ebbe protagonista uno scienziato di prim'ordine, Nazzareno Strampelli, che merita memoria.
...e ne fece di pessime: pena di morte e Tribunale speciale
L'Italia, però, non era solo quella delle relazioni internazionali, dei viaggi del capo di governo all'estero, dei ricevimenti aulici e delle innovazioni. Vi era anche l'Italia della “politica”. Capo di un governo di fedelissimi e, tramite il “fratello fedifrago” Roberto Farinacci, posto alla guida del Partito, Mussolini dedicò gli ultimi mesi del 1926 ad abbattere quel che rimaneva dello Stato liberale e dei diritti politici enunciati dallo Statuto albertino del 1848. Per un settantennio essi erano stati via via tradotti in leggi da un Parlamento fondato su libertà e immunità speciali dei suoi componenti.
Primo bersaglio fu l'elettività dei consigli comunali, sostituiti con podestà di nomina prefettizia, cioè governativa. Ai consigli provinciali, dormienti per un po', subentrarono i rettorati. Poi fu la volta di tre colpi di mano che in poche settimane annientarono il regime liberale.
Il 5 novembre 1926, in riposta all'“attentato Zamboni” del 31 ottobre, il governo deliberò l'immediato scioglimento di partiti e sodalizi antifascisti, la soppressione di quotidiani e periodici di opposizione, l'istituzione del confino di polizia per oppositori anche non iscritti a partiti politici (i massoni vennero condannati solo perché tali) e severi controlli sull'espatrio. Il 9 novembre i deputati arroccati fuori dall'Aula (gli “Aventinisti”) a norma del regolamento furono dichiarati decaduti per assenteismo. Persero l'immunità e vennero sottoposti a restrizioni e perquisizioni domiciliari. La loro corrispondenza fu intercettata. Parecchi subirono il “bando” dalla città di residenza o dal collegio nel quale venivano eletti. Il regime usò la Milizia, l'Ovra e lasciò briglie sciolte ad atti squadristici. Molti antifascisti furono costretti a rifugiarsi all'estero. Fu il caso del socialista Arturo Labriola e del popolare Alcide De Gasperi che, bandito da Trento, cercò rifugio Oltre Tevere.
Sui 101 deputati che avevano costituito l'“Aventino” 55 vennero colpiti da “bandi”, lanciati anche contro ex parlamentari quali Nullo Baldini, Ulderico Mazzolani, Luigi Montemartini, Francesco Saverio Nitti (già presidente del Consiglio, bandito da Muro Lucano, Melfi e Potenza, sua area di riferimento), Felice Quaglino, Francesco Zanardi, per sette anni sindaco di Bologna, e Giovanni Zibordi, che al congresso socialista di Ancona nell'aprile 1914 aveva tenuto bordone a Mussolini per deliberare l'espulsione dei massoni dal PSI.
Il peggio seguì.
La legge 25 novembre 1926, n. 2008 sancì che chiunque commettesse “un fatto” diretto contro la vita, l'integrità personale o la libertà personale del re o del reggente era punito con la pena di morte. La stessa pena venne inflitta se “il fatto” era diretto contro la vita, l'integrità o la libertà personale della regina, del principe ereditario e il capo del governo. Era passibile di pena di morte non solo il regicida ma anche chi ordiva “un fatto” senza poi eseguirlo. Fu il caso dell'anarchico Michele Schirru.
Il regime liberale aveva abolito la pena di morte con il codice penale elaborato dal massone Giuseppe Zanardelli (1889) e varato dal governo presieduto da Francesco Crispi. Ma già da anni la pena di morte, a volte irrogata, non veniva eseguita, se non per reati previsti dal codice penale militare. Dunque nel 1926 l'Italia voltò pagina: all'indietro.
La stessa legge stabilì che chiunque ricostituisse, anche sotto forma o nome diverso, organizzazioni o partiti disciolti per ordine della pubblica autorità, era punito con la reclusione da tre a dieci anni, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Identica pena colpiva chi si limitava a fare «in qualsiasi modo, propaganda della dottrina, dei programmi e dei metodi d'azione di tali associazioni, organizzazioni o partiti». Bene si comprende perché la storiografia dell'epoca si sia dedicata al passato remoto o si sia genuflessa al regime, eludendo la storia dei partiti politici e del Parlamento.
Gli oppositori italiani riparati all'estero furono puniti con perdita della cittadinanza e confisca dei beni.
Ma chi doveva indagare, escutere e condannare? Con la legge 12 dicembre 1926, n. 2062 venne istituito il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, unico in tutto il regno ma all'occorrenza diviso in più sezioni, con presidente, vicepresidenti e giudici nominati dal ministro della Guerra che, vedi caso, era Mussolini. Presidente e vicepresidenti erano generali mentre i giudici erano consoli della milizia. I difensori erano militari di grado inferiore a capitano, forse un po' intimiditi. Il Tribunale speciale fu concepito come strumento temporaneo. Durò sino al 25 luglio 1943. La relazione sul suo primo quinquennio dichiarò che aveva dato di sé «prove sotto ogni aspetto eccellente: severo solo quando la severità era consigliata dalle più alte esigenze della giustizia. Negli altri casi, la maggior parte, si mostrò assai spesso più indulgente del giudice ordinario». Il repertorio delle condanne inflitte dice l'opposto.
Nello stesso 1931 venne stabilito che tutti i suoi atti, anziché dal ministro della Guerra, sarebbero promanati direttamente «da colui che assomma ed impersona il supremo potere del Governo».
Sembra arduo negare che a quel punto, sulla fine del 1926, l'Italia fosse un regime autoritario tendente al totalitario, con l'unico ostacolo della Monarchia e della chiesa cattolica con la quale l'11 febbraio 1929 il governo sottoscrisse i Patti Lateranensi. La stampa era sotto controllo, erano permessi un solo partito, quello nazionale fascista, e un unico sindacato. Le associazioni non ancora vietate, come Rotary Club, circoli ricreativi e la stessa Azione cattolica, erano sotto controllo, spiati da informatori dell'Ovra. La tessera del partito era indispensabile per concorrere a impieghi pubblici. Insomma, come aveva detto il filosofo Giovanni Gentile, una volta tanto chiaro e comprensibile, e poi riecheggiato da Mussolini: «Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, niente contro lo Stato.» Il duce, però, non riuscì a imporre i fasci littori alle Forze Armate, che continuarono a giurare fedeltà unicamente al Re e ai suoi legittimi discendenti. Quando fu il momento, Vittorio Emanuele III revocò Mussolini e lo sostituì con Pietro Badoglio, marchese del Sabotino, duca di Addis Abeba, Maresciallo dell'Impero, che in poche ore sciolse il Pnf, il Gran Consiglio del fascismo, il Tribunale speciale e, a cascata, una miriade di enti e strumenti di un regime che nessuno scese in piazza a rivendicare.
Un'era di breve durata
Il 3 dicembre 1926 il “Duce” ordinò che all'anno civile, in numeri arabi, si aggiungesse, in numeri romani, quello dell'“era fascista”, a datare dal 28 ottobre 1922, giorno della mai avvenuta “marcia su Roma”. Quell'era durò 17 anni, alla fine dei quali l'Italia era “in tocchi”, come il Re disse a Mussolini il 25 luglio 1943. Chi poteva e doveva prevedere la deriva verso il regime non fece nulla di valido per impedirlo. Chiamati alle urne, i cittadini lo approvarono nel 1929 con quasi il 99% dei suffragi e altrettanto fecero nel 1934. Nel 1939 Mussolini non sentì neppure il bisogno di consultarli. Il Senato rimase di nomina regia e vitalizio, mentre la Camera elettiva venne sostituita con quella dei fasci e delle corporazioni. Il regime sembrava eterno. Crollò poco dopo. Non per virtù degli antifascisti, ma per la sconfitta in una guerra voluta da un regime militarmente impreparato. Per vincere non bastavano né “otto milioni di baionette”, né canti guerrieri.
Aldo A. Mola
DIDASCALIA DELLA FOTOGRAFIA : Vittorio Emanuele III, “il Re Borghese”, e Benito Mussolini in un campo durante la “Battaglia del grano”.
Artefice di quella campagna fu Nazzareno (si firmava Nazareno) Strampelli (1866-1942), agronomo, genetista, validamente aiutato dalla moglie, Carlotta Parisani, discendente per via di madre da Luciano Bonaparte, principe di Canino. Maestro massone nella loggia “Giuseppe Petroni” di Terni dal 1907, Strampelli si dedicò alla selezione di specie di grano sempre più resistenti e ricche, esportate in tutto il mondo, atte ad aumentare di decine di volte la redditività delle aree destinate alla cerealicoltura. Aiutato dal senatore Raffaele Cappelli (1848-1921) e iscritto “ope legis” al Pnf dal 1925, rifiutò il seggio parlamentare ma nel 1929 accettò il laticlavio senatoriale, anche per la stima, profondamente ricambiata, di Vittorio Emanuele III, promotore dell'Istituto Internazionale dell'Agricoltura, precursore della FAO, che non per caso ha sede in Roma. Strampelli non fece mai brevettare le numerosissime conquiste scientifiche, che gli avrebbero procacciato una enorme fortuna. Come il “fratello” Alberto Beneduce, era pago di dedicare la sua intelligenza al bene inscindibile della Patria e dell'Umanità. È considerato giustamente il precursore della “rivoluzione verde”.
A.A.M.