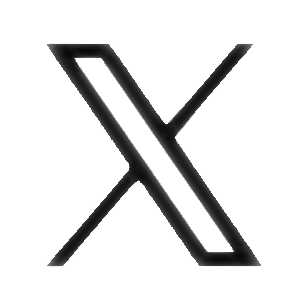Prima degli algoritmi la tecnologia ha rubato una parola agli dèi
La parola avatar non nasce con la tecnologia. Non nasce con i videogiochi, né con i social network, né con l’intelligenza artificiale. Nasce molto prima di tutto questo, in un tempo in cui l’uomo non programmava macchine ma si interrogava per il senso dell’esistenza. Avatar è una parola sanscrita antichissima, Avatāra significa “discesa”, “incarnazione”, “manifestazione nel mondo”. Nella tradizione induista indica il momento in cui una divinità scende sulla terra assumendo forma visibile per ristabilire l’ordine quando il caos prende il sopravvento. Non è un simbolo astratto e’ una presenza reale che entra nella storia.
L’avatar non è una maschera ma un essere che appare nel mondo mantenendo però una natura diversa, superiore, invisibile. Questo è il punto che rende inquietante e affascinante il suo uso contemporaneo.
Quando la tecnologia ha avuto bisogno di una parola per indicare una presenza digitale che rappresentasse l’essere umano nello spazio virtuale, non ne ha inventata una nuova. Ha scelto una parola millenaria. Non a caso. Perché nessun termine moderno avrebbe avuto la stessa forza evocativa. Un avatar digitale è infatti una presenza che agisce senza essere corpo. Un’entità che “è lì” senza esserci davvero. Una proiezione che parla, si muove, interagisce, ma non possiede materia.
Il parallelismo è evidente.
Così come l’avatar religioso era la discesa del divino nel mondo umano, l’avatar tecnologico è la discesa dell’identità umana nel mondo digitale. In entrambi i casi si tratta di una traslazione dell’essere, di un passaggio da un piano a un altro.
Ma qui avviene lo slittamento più delicato.
Nel pensiero antico l’avatar aveva uno scopo etico, ristabilire l’armonia, riportare l’ equilibrio, proteggere l’umanità. Era un evento raro, sacro, carico di responsabilità. La sua comparsa non era mai neutra.
Nel mondo tecnologico, invece, l’avatar diventa quotidiano, moltiplicabile, replicabile all’infinito. Non porta più ordine, ma rappresentazione, non responsabilità, ma funzione.
In questo passaggio qualcosa si perde.
Perché quando la tecnologia adotta parole antiche, non lo fa solo per bellezza linguistica. Lo fa perché quelle parole parlano ancora all’inconscio collettivo. Portano con sé un’aura, una profondità, una legittimazione invisibile.
Dire avatar non è come dire profilo o immagine. Avatar suggerisce presenza, identità, quasi autorità. Suggerisce che ciò che vediamo non è solo una figura, ma una forma dell’essere.
Potrebbe essere una sottile manipolazione?
Quando una parola carica di significato spirituale viene usata per definire un oggetto tecnologico, si crea una confusione silenziosa tra ciò che rappresenta e ciò che è. L’immagine comincia a sostituire la persona. La proiezione prende il posto dell’identità. La simulazione diventa percepita come presenza.
Non è un caso che oggi si parli di avatar che parlano al posto nostro, lavorano al posto nostro, partecipano al posto nostro. Come se l’essere umano potesse davvero essere trasferito, delegato, duplicato.
Ma l’avatar, nella sua origine più profonda, non sostituiva mai l’uomo. Era eccezione, non norma. Evento, non sistema.
La tecnologia, invece, tende a rendere permanente ciò che un tempo era sacro e raro.
Forse è per questo che molte parole del digitale non sono nuove. Sono antiche. Recuperate dal fondo della storia. Riattivate perché contengono ancora una potenza simbolica capace di rendere accettabile ciò che altrimenti apparirebbe freddo, meccanico, disumano. L’intelligenza artificiale non ha creato nuovi miti, ha solo riutilizzato quelli antichi.
Quando una civiltà smette di creare simboli propri e comincia a prendere in prestito quelli millenari, significa che sta cercando legittimazione in qualcosa che la precede.
Avatar, oggi, è molto più di una parola tecnologica. È lo specchio di un tempo in cui l’uomo tenta di diventare presenza senza corpo, voce senza volto, identità senza limite.
Ma nessuna simulazione, per quanto sofisticata, potrà mai sostituire la profondità dell’essere umano reale.
Perché l’uomo non è un avatar.
È presenza viva, fragile, irripetibile.
Forse ricordare l’origine delle parole è il primo modo per non smarrire anche noi stessi.