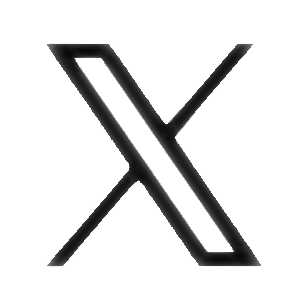La crisi dell’Occidente come crisi di sguardo storico
Di Paolo Falconio - Miembro del Consejo Rector de Honor y conferenziere en la Sociedad de Estudios Internacionales (SEI)
In questa follia collettiva che noi chiamiamo occidente, la storia ci pone di fronte alle sue fratture sistemiche.
Il filo conduttore non è l’antiamericanismo o il rifiuto dei valori democratici, bensì la denuncia di una cecità strutturale dell’analisi occidentale, incapace di pensare il mondo al di fuori delle proprie categorie concettuali, filosofiche e morali. È una cecità cognitiva prima ancora che politica.
Le dinamiche degli Stati, per di più quando sono imperi sono paragonabili a movimenti tettonici: non agiscono secondo la temporalità breve del ciclo elettorale o del dibattito mediatico, ma secondo pressioni profonde, lente, cumulative, che solo in apparenza restano invisibili. Quando emergono, lo fanno sotto forma di “terremoti” storici.
L’Occidente contemporaneo, immerso in un presentismo radicale, ha smarrito la capacità di riconoscere queste forze di lungo periodo
Una postura che produce analisi “occidento-centriche” che non sono semplicemente parziali: sono strutturalmente inadatte a cogliere fenomeni imperiali, perché pretendono di leggere la storia con categorie nate per contesti nazionali, liberali e post-imperiali.
Le nostre analisi sono intrise di filosofia politica prodotta in occidente e anche con limiti cognitivi evidenti sulla stessa nostra produzione.
Così accade che si proceda a narrazioni limitate e limitanti sia delle attuali dinamiche interne democratiche, sia di come l’ Occidente collettivo si rapporti al mondo che continua ad essere letto come se fosse un’estensione incompleta dell’Occidente stesso, trasformando la differenza storica in arretratezza, e la divergenza politica in anomalia
L’Occidente continua a pensarsi attraverso Montesquieu, Rousseau e Tocqueville, ma agisce nel mondo attraverso Hobbes. La contraddizione tra l’ideale democratico e la pratica statuale – soprattutto sul piano internazionale – non è un accidente, ma una frattura costitutiva. Il “Leviatano” resta il vero fondamento dello Stato moderno, mentre le democrazie occidentali appaiono incompiute, fragili, spesso incoerenti con i principi che dichiarano di incarnare. L’incapacità di riconoscere questa ambiguità produce narrazioni autoassolutorie e politicamente infantili.
L’ ignoranza di questa condizione e una classe dirigente carente sotto molti aspetti, ci ha portato nei percorsi dell’ assurdo. Sognavamo l’ uomo nuovo senza storia, androgino e abbiamo partorito mostri. L’ illusione antropologica di società smontabili e ricostruibili a piacimento, di popoli riducibili a individui astratti. L’idea assurda che l’uomo possa essere separato dalla storia, dal corpo sociale, dalla memoria, fino a diventare materiale neutro per l’ingegneria sociale.
Abbiamo chiuso gli occhi di fronte alle concentrazioni di capitale, finendo per scordare Tocqueville che pensava che una vera democrazia si sarebbe potuta esprimere solo negli USA perché lì ancora non vi erano tali concentrazioni.
Abbiamo ignorato le nostre contraddizioni interne, smarrendo la consapevolezza che la democrazia non è solo una forma istituzionale, ma un equilibrio sociale fragile, storicamente determinato.
Sul piano internazionale continuiamo a parametrare il mondo a noi stessi. A volte lo facciamo indossando la maschera della democrazia, a volte, come accade oggi, senza filtro alcuno.
Ma il minimo comune denominatore è che siamo convinti che non ci siano altri percorsi sinaptici che non siano i nostri. Non parlo di valori che è un tema ormai per reietti.
Con queste menti abbiamo approcciato la Russia, convinti che la sconfitta Ucraina avrebbe liberato il popolo russo avviandolo a una metamorfosi liberale e liberatoria ( metamorfosi che i russi hanno avuto sotto Eltsin e non ne hanno affatto un buon ricordo). Abbiamo pensato alla Russia come un pezzo di terra che andava dagli Urali al Pacifico abitato da esuli del Lussemburgo. Incapaci di comprendere che dentro quei confini abitano popoli, storie, percorsi e identità che non vogliono sparire, ma anzi riaffermano con forza la loro esistenza. Kissinger che era un uomo non certo ingenuo o candido ci aveva ammonito: L’ URSS è scomparsa, ma non i Russi. L’Occidente ha confuso la fine di un regime con la dissoluzione di una civiltà storica, di un’autocoscienza imperiale, di una specifica visione del proprio ruolo nel mondo.
La guerra in Europa ci ha riportato brutalmente alla storia. Ed è la Storia ha colpirci perché il conflitto si è subito caratterizzato come conflitto tra identità, potenze e memorie, non come semplice deviazione da un presunto ordine naturale liberale.
Lo stesso stiamo facendo in Iran. Produciamo analisi su analisi e scenari improbabili, mostrando un’ ignoranza imperdonabile di quello che è uno dei più antichi imperi della storia. Dove le donne sì, si ribellano, ma portando gioielli zoroastriani. La loro ribellione non è una trasposizione del femminismo liberale, ma un fenomeno radicato in simboli, tradizioni e memorie proprie. Dove i curdi sono esclusi dal potere dal XVI secolo perché tradirono l’ impero alleandosi con i Turchi. La politica iraniana contemporanea risulta incomprensibile senza conoscere stratificazioni storiche secolari, memorie collettive di alleanze e tradimenti, strutture di potere consolidate attraverso generazioni. L’Occidente tende a leggere questi fenomeni attraverso categorie contemporanee – minoranze oppresse, diritti umani, democratizzazione – perdendo la dimensione storica profonda che li rende intelligibili.
Hanno una Costituzione, e un sistema di sicurezza a strati difficile da smontare. Soprattutto sono un popolo imperiale, il che vuole dire essere predisposti alla sofferenza per riaffermare la loro primazia.
Molte narrazioni occidentali, faticano persino a concepire la resilienza come valore politico e non come semplice oppressione subita.
Noi anche qui inneggiamo al coraggio del popolo iraniano, ma non capiamo che la loro protesta non è la nostra. Altrimenti non penseremmo allo Shah come alternativa al Regime degli Ayatollah.
Al di là delle capacità iraniane che pur vi sono, 90 milioni di persone su un un territoro di 1.600.000 km quadrati , una cultura millenaria raffinatissima seduta su riserve energetiche imponenti e circondata su tre lati da Nazioni affini, ecco noi pensiamo agli iraniani come a cittadini del Lussemburgo.
Quello che ci sfugge è la storia e la storia è fatta da popoli.
L’ Iran è un problema perché come sosteneva Kissinger è una causa e non una Nazione normale. La causa iraniana non è solo quella palestinese, su quella penso che si possa lavorare, la causa iraniana è decidere il proprio percorso di sviluppo come Nazione.
Il Regime teocratico credo abbia esaurito la sua funzione storica, ma se davvero volessimo liberare le forze migliori dell’ Iran, dovremmo essere consapevoli che abbiano a che fare con un popolo fiero e identitario.
Invece noi continuiamo a pensarlo come una Libia un po’ più grande
Finché l’Occidente continuerà a pensare Russia e Iran o anche alla Cina (e ad altri attori internazionali) come versioni incomplete di se stesso – come “Lussemburghi mancati” – continuerà a produrre analisi sbagliate, politiche fallimentari e, soprattutto, conflitti che credeva di aver archiviato per sempre. Visto che proliferano le analisi Geopolitiche , sarebbe bene ricordare che in Geopolitica gli Stati non sono solo istituzioni, ma organismi storici.
Non solo, credo che molto ci sia da fare perché le nostre democrazie possano dirsi compiute, ma parallelamente credo che come società occidentali dovremmo arrivare ad una sorte di “pluralismo epistemologico”: il riconoscimento che esistono molteplici razionalità politiche, diverse temporalità storiche, tradizioni intellettuali non riducibili l’una all’altra. Questo non implica rinunciare a qualsiasi criterio di giudizio, ma richiederebbe lo sforzo preliminare di comprendere le logiche interne di sistemi politici e culturali diversi prima di valutarli secondo i nostri standard. Il vero punto cieco dell’Occidente non è la mancanza di valori, ma la pretesa che i propri siano l’unica grammatica possibile della storia contemporanea, negando al contempo la storia stessa. È una crisi di civiltà nel senso più profondo: una civiltà che ha smesso di riconoscere la storia come dimensione tragica, conflittuale e plurale dell’esperienza umana.
Paolo Falconio
Tutti i diritti riservati