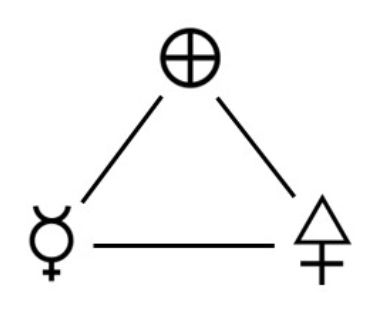di Lavinia Felicioni
Il simbolo perviene a noi contemporanei dalla notte dei tempi ovvero, per meglio dire, catapultato fino a noi da un tempo e da uno spazio indefiniti; sicuramente da un’era arcaica, nella misura in cui il simbolo pertiene ad un topos originario del nucleo strutturale dell’umanità nella sua formazione embrionale.
Così come, per altro verso, va evidenziato che il simbolo attiene a svariati circuiti del sapere e non è facilmente collocabile: antropologia, arte, psicologia, psicoanalisi, filosofia ma anche scienza e metafisica sono solo alcuni degli ambiti entro i quali si può tentare un approccio al simbolo.
L’etimo simbolo ha origine molto profonda e complessa con radici semantiche particolarmente intricate. Deriva dal latino symbolum, e a sua volta dal greco antico sýmbolon (σύμβολο). Questo fonema trae la propria radice dal greco symballo, composto dai termini insieme e gettare; traducibile in italiano con la formula mettere insieme.
Nel contesto dell’antica Grecia, infatti, questa espressione faceva riferimento all’usanza di dividere alcuni oggetti in due metà per poi consegnarle, ad esempio, a persone appartenenti a differenti nuclei familiari, le quali avrebbero potuto in seguito ricomporle in segno di riconoscimento e di legame affettivo.
In questo senso, la radice greca esprime l’idea di ricomporre o far coincidere, che sottolinea la natura intrinseca del simbolo: il suo potere di unificare e connettere realtà diverse ovvero apparentemente distinte.
Nel corso dei millenni, tale espressione ha assunto il significato di sostituire, stare al posto di qualcos’altro, talvolta avvicinandosi al concetto di segno; anche se non c’è univocità sul punto, pur tuttavia per la maggioranza degli esperti i termini simboli e segni fanno riferimento a realtà comunque distinguibili.
In prima analisi, al fine di comprendere il senso etimologico del termine, può essere utile esplorare le diverse riflessioni di alcuni tra i più noti psicoanalisti. Premesso quanto sopra, si evidenzia sin da subito che la funzione primaria di un simbolo è squisitamente evocativa: il suo ruolo è allusivo più che informativo. È come se il simbolo, più che disvelare, amasse racchiudere al suo interno il proprio mistero, in qualche modo custodendolo. Il simbolo più che rivelare cela, o se vogliamo, cela e rivela contemporaneamente, in guisa ineffabile, lasciando al singolo la capacità di conoscenza, di trasformazione e di crescita personale. In tal senso, il simbolo può essere individuato come un ponte lanciato tra conscio ed inconscio: è il depositario di contenuti e significati ineffabili che il soggetto ha il compito di portare alla luce.
Il simbolo risponde, per così dire oniricamente, ad una certa congenita quanto ancestrale esigenza dell’individuo, a rappresentare fedelmente il mondo esteriore sulla base di fantastiche suggestioni provenienti da allusioni simboliche.
In particolare, seguendo l’insegnamento di Sigmund Freud, il simbolo rappresenta un elemento concreto - ovvero un’immagine visiva - che sostituisce un’idea inconscia: orbene tale processo di sostituzione consente alle idee inconsce di emergere nella dimensione della coscienza. Per Freud la componente simbolica emerge, per lo più ma non solo, nel sogno: in altre parole il simbolo si manifesta e viene alla luce grazie alla dimensione privilegiata della componente onirica.
Per Carl Gustav Jung, invece, è fondamentale il concetto di inconscio collettivo, il luogo nel quale risiedono i simboli universali che Jung denimina archetipi: schemi arcaici immutabili, che trascendono l’individuo ma che sono riconosciuti dal singolo nel proprio vissuto e tramandati dall’umanità fin dalla notte dei tempi. In tal senso, il simbolo è connesso alla dimensione comunitaria e alla sfera della psiche umana collettivamente intesa.
Ciò implica che, secondo Jung, un simbolo è vivo finché cela un significato parzialmente inespresso. Nella misura in cui viene decodificato, il simbolo cessa di esistere e si trasforma in un segno che assumendo un valore storico, si trasforma in segno convenzionale. In altre parole, se ed in quanto questo significato assumesse una forma univoca e decodificata, il simbolo morirebbe e si trasformerebbe in un segno convenzionale, conservando soltanto un valore storico.
Tale autore afferma che ”il simbolo è la migliore definizione possibile di qualcosa di relativamente sconosciuto”: in tal senso il simbolo mette in relazione, o per meglio dire in comunicazione, il conosciuto con ciò che è ignoto, sconosciuto all’umanità, per svelarlo. D’altra parte, ciascuno di noi è - per sé stesso - conosciuto e, al contempo, in parte sconosciuto: il celeberrimo: Nosce te ipsum rimane - in tal senso - più un proposito, un obiettivo da raggiungere, un traguardo al quale pervenire piuttosto che una certezza. Il simbolo, pertanto, ha la funzione di mettere in comunicazione la coscienza con l’inconscio, al fine di congiungere le opposte polarità e di aprire così i nuovi percorsi dell’evoluzione della psiche.
Peraltro, nel corso dei secoli, svariati autori – nei vari ambiti dello scibile e da diverse prospettive prescindendo dalla psicanalisi – hanno approcciato e analizzato il simbolo: tra gli altri Goethe, Bachofen, Cassirer e Hegel, per citarne alcuni e senza avere la pretesa di essere esaustivi. In particolare taluni esponenti hanno avuto il merito di accentuare la distinzione del simbolo dal segno. Più in generale il simbolo, che storicamente precede il segno, può essere pensato come l’organo necessario del pensiero: il che val quanto dire che l’individuo “pensa per simboli”, avendo il merito peraltro di mettere in relazione ogni singolo elemento con gli altri.
Ora, andando più indietro nel tempo e focalizzando l’attenzione sul Simposio, con riferimento all’archetipo dell’unità nell’androginia, Platone narra che l’unità originaria, una volta rotta, proruppe nella dualità dei due sessi: ne deriva che, nella misura in cui ciascuno è la metà di un umano (cioè un symbolon), tale porzione - che è la risultante, o se vogliamo la vittima, del taglio netto della primaria unità - è alla costante ricerca dell’altra restante metà della quale è deprivata.
Come già accennato la radice etimologica del termine in questione va ricercata nel termine greco symballò: unire, collegare, mettere a paragone e quindi mettere insieme qualcosa che, originariamente presente in forma unitaria, è stato posteriormente suddiviso.
Pertanto iI simbolo si caratterizza con l’idea del rinvio: il che, con espressione latina, possiamo rendere con la locuzione aliquid pro aliquo (letteralmente: qualcosa per qualcos’altro).
In termini più generali il simbolo è la primigenia forma di rappresentazione e comunicazione della realtà. Da qui due considerazioni: il grado di civiltà delle società arcaiche si misura dalla loro rispettiva capacità di elaborare i propri simboli e, d’altra parte, questi non vanno confusi con i segni, che attengono alla comunicazione orale e scritta, mentre il simbolo va collocato in un’era anteriore priva della scrittura o della comunicazione orale latamente intesa.
L’aspetto fondamentale del simbolo consiste nel riferirsi a qualsivoglia elemento che susciti la percezione di un’idea distinta da ciò che è il suo più cogente aspetto palese e, per così dire, tangibile: trattasi di qualsiasi rappresentazione di un evento o di un oggetto che rimanda ad un’idea comune, capace di essere percepita alla stessa maniera da una pluralità di soggetti ovvero da una comunità.
Né va dimenticato come il simbolo abbia un peculiare aspetto dinamico o, per così dire cinetico. Valgano in proposito due esempi su tutti: la rappresentazione del fulmine, da parte di talune tribù di nativi americani, in forma di serpente e la rappresentazione dell’ostia da parte dei cristiani come corpo (e sangue) di Cristo. Orbene, se nel primo caso, i nativi procedono a fagocitare il serpente, nell’evidente tentativo di governare un fenomeno che non è nella loro disponibilità, nel secondo caso siamo in presenza, come è noto, del fenomeno della transustanziazione, in base al quale - peraltro - l’assunzione dell’ostia consacrata comporta la divinizzazione dell’individuo, l’appropriazione della deità.
Collocando il simbolo simbolo tra immanenza e trascendenza potremmo altresì riflettere su come l’intelletto dell’uomo dialoghi incessantemente tra Natura (Dio) e cultura (società), immerso nella simbologia, ponte entro le due dimensioni, nell’ambito delle quali, l’Adam, tenta di operare una sommaria azione di discernimento, nella finalità di imprimere e sviluppare una sua propria volontà e individuale coscienza.
La simbologia è costantemente attiva ed operante, sia nell’inconscio individuale che in quello collettivo; va poi da sé che si tratti di un limite dell’uomo non riconoscere la propria natura divina nel piano fisico, caricandosi di contenuti fuorvianti e ottundendo la sua visione con impurità di ogni tipo.
La valenza del simbolo è quindi quella di aiutare l’uomo nel suo processo di riconnessione con il trascendente, ingenerandogli il ricordo di se e del Sé.
Tuttavia il simbolo, non informa in modo diretto, bensì richiama (racchiude ed allude) a concettualità di tipo molto profondo alle quali si assurge in base al proprio livello di evoluzione e di coscienza, teorizzazioni svincolate dal potere evocativo della parola e piuttosto legate a quello dell’immagine, a loro volta manifestazione dell’archetipo, cioè della forma e del modello originario.
Il simbolo è infatti il ponte che conduce l’esperienza umana alla sublimazione e al superamento di aspetti meramente estetici ed esteriori, trascendendoli e cogliendone la loro profonda valenza intrinseca e collegandola alla realtà perenne e, in qualche modo, al simbolo e al mito.
In questa accezione, il simbolo non rappresenta - pertanto - solo un elemento della comunicazione (del quale si avvalgono anche le scuole iniziatiche per perpetrare e perpetuare la Tradizione), bensì un elemento che veicola ed è il significante di contenuti di tipo ideale, proprio andando oltre i limiti del linguaggio e avvalendosi di analogie per condurci oltre gli aspetti del razionale.
Essere aperti all’universo simbolico, per propria costituzione sostanziale e morfologica, significa avere l’opportunità di andare oltre l’universo percettivo ordinario, per connettersi - attraverso la parte inconscia - ad un campo più esteso di energia e coscienza, assurgendo a teorizzazioni di tipo metafisico, molto difficili da cogliere, finanche da lambire dall’ Intelletto umano.
Giova ribadire, ancora una volta, come l’etimo simbolo provenga dal latino symbolum derivante - a sua volta - dal greco antico symbolon che ci conduce alla significanza di mettere insieme due parti distinte, rappresentando – idealmente – la nostalgia di un qualcosa che va ricongiunto: due estremità di un oggetto, di un fonema, di un pittogramma, di un ideogramma o di un qualsiasi monile o di un oggetto (nella Grecia antica preferibilmente in terracotta) le quali venivano, idealmente, ma anche concretamente, affidate a due individui, famiglie, ovvero clan, per suffragare il ricordo dell’osservanza e del rispetto di un accordo, di un giuramento ovvero di un patto. Il simbolo richiama, quindi, ciò che i latini sapientemente illustravano con la “ reductio ad unum”.
Il Simbolo come metodo
Il simbolo si può anche rappresentare come un insieme di figure, immagini, gesti che interpretati correttamente corrispondono ad un significato ben preciso.
L’uomo, per sua natura, ha sviluppato nel tempo la necessità di comunicare, utilizzando varie forme, sia verbali che - successivamente - scritte.
Analizzando questo ragionamento si può dedurre che già le lettere normalmente utilizzate per scrivere nel quotidiano sono, in origine, sostanzialmente dei simboli, riconosciuti a livello comunitario come segni. Tali lettere, predisposte in varie sequenze, generano dei codici chiamate volgarmente lingue. Ora, analizzando questo metodo possiamo inoltrarci in alcune valutazioni.
In era arcaica - approssimativamente tra il 6500 e il 4000 A.C. - l’uomo per poter lasciare testimonianza della propria esistenza in vita, ebbe a disegnare ed a scolpire modo simbolico delle rappresentazioni del quotidiano.
In epoca successiva l’esempio più conosciuto e famoso ma soprattutto affascinante da analizzare sono i testi dell’antico Egitto.
Essi raggruppano un insieme di immagini, disegni, sculture, che - a loro volta decifrate - risultano generare dei manoscritti. Tutto ciò senza l’utilizzo delle lettere (come detto precedentemente), ma usufruendo delle iconografie che raccontano in alcuni casi la vita quotidiana degli appartenenti alle classi sociali più agiate; in altri casi invece essa viene rappresentata una posizione ben precisa del protagonista della scrittura stessa.
Un esempio eclatante è il cartiglio, questo essendo un anello chiuso nel quale al suo interno viene inserito il nome del Faraone (Fig.1: Cartiglio di Ramses II).
Volendo brevemente analizzare l’immagine, e non entrando nel merito dei pittogrammi sotto forma di geroglifici interni, la raffigurazione del cartiglio è l’ovale sostenuto da un’asta sotto il quale rappresenta “Il potere universale del Dio Sole”, rappresentato in forma terrestre dal Faraone in persona.
Eseguendo un salto temporale, avvicinandoci quindi ai tempi nostri e in particolare in epoca medievale, per una forma distorta l’utilizzo del simbolo era considerato un metodo vero e proprio di comunicazione segreta.
In un periodo dove l’uomo ebbe modo di sviluppare una più sottile forma di comunicazione, ma colma di pregiudizi e valutazioni delle frasi o manoscritti di personalità più colte, l’uso del simbolo si trasformò in espressioni di pensieri e considerazioni che per motivi religiosi e politici non potevano essere divulgate.
La più famosa istituzione che in questo periodo storico fece uso in modo consistente del simbolo fu la classe considerata una maestranza del tempo: costoro, comunemente chiamati Scalpellini o Muratori erano più spesso in realtà dei veri e propri architetti, che con la propria esperienza riuscirono a creare monumenti, e in particolare cattedrali, che al giorno d’oggi custodiscono ben visibili simboli apparentemente inspiegabili o incomprensibili.
Entrando nel merito e nello specifico, queste figure utilizzavano i simboli come una vera e propria forma espressiva di linguaggio che, per non essere divulgata e riconosciuta, manteneva segreti i significati dei simboli medesimi, insegnando - da bocca a orecchio - soltanto ai propri apprendisti, e poi ai compagni, i codici che si generavano.
Questo metodo, secondo alcuni ricercatori viene attribuito e ereditato da questa classe dalla scuola ermetica di Pitagora.
In tempi più recenti, queste unioni di persone a mano a mano, per motivi legati al diminuire degli ingaggi da parte del loro massimo committente ossia la Chiesa, continuarono la costruzione non più di cattedrali, ma bensì dell’essere umano sotto forma spirituale. Questo cambiamento o mutazione generò la necessita di aumentare ancora il livello di segretezza di questo lavoro che - da operativo e fattuale - divenne prettamente e squisitamente speculativo.
Nell’anno 1717 ovvero secondo altra fonte tradizionale, nel 1723, queste gilde di Muratori ormai non più operativi ma bensì spirituali e speculativi, fondarono ufficialmente la società (all’epoca) segreta denominata Massoneria o dei Liberi Muratori.
Al suo interno, vi erano non più costruttori materiali, bensì persone di elevata cultura e soprattutto con una spiccata apertura mentale, questa ovviamente contrapposta alla Chiesa non avendo al suo interno nessun dogma. Pertanto, in questa fase, l’utilizzo del simbolo venne di vitale importanza per riuscire a comunicare tra gli appartenenti della stessa mantenendo il segreto.
Successivamente altre società segrete, non meno importanti ma semplicemente meno conosciute, ne fecero anche loro un vero e proprio metodo di comunicazione.
Questa forma di segretezza dell’utilizzo del simbolo viene comunemente fatta rientrare nell’ambito dell’esoterismo: esso rappresenta la consapevolezza, o meglio la conoscenza, la gnosi degli appartenenti alle varie società segrete di saper riconoscere nei simboli i vari significati celati da essi.
Esempio eclatante di simbologie esoteriche possiamo nella banconota da un dollaro statunitense. Il numero 13, emblematico per il suo legame con la storia inerente ai Templari (considerati da taluni gli antesignani della Massoneria) viene riportato svariate volte: 13 le stelle sopra l’aquila, 13 le frecce impugnate negli artigli di destra, come sempre 13 le foglie del ramo impugnato negli artigli di sinistra, come le righe del dorso della medesima. Anche la piramide è costituita da 13 righe di mattoni.
Un altro simbolo visibile e il triangolo con al suo interno l’occhio, simbolo di onniveggenza.
Lo stesso George Washington, al quale come padre fondatore degli Stati Uniti venne dedicata questa banconota, in realtà è legato e collocabile all’interno della Libera Muratoria in virtù del suo grado di Maestro con il massimo della specializzazione nella Massoneria statunitense. Così come, d’altra parte, aderenti alla Libera Muratoria dell’epoca furono gran parte dei padri fondatori degli attuali Stati Uniti d’America.
Questo esempio è solo uno dei tanti nel comprendere come la Massoneria utilizzi i simboli per comunicare in modo segreto con gli appartenenti alla medesima.
Volgendo al termine questa breve disamina intorno al simbolo possiamo concludere evidenziando come esso, lungi dall'essere utilizzato per la comunicazione in modo chiaro e palese alla collettività, viene semmai impiegato come via riservata di comunicazione per custodire i segreti che non devono essere soggetti alla comprensione e divulgazione comunitaria, sottraendone la sua disponibilità al pubblico dominio. Ciò al fine di preservare la riservatezza, allo scopo di impedire che le conoscenze destinate a pochi “eletti”, ovvero gli iniziati, potessero divenire appannaggio della moltitudine dei profani se non per la pericolosità di accogliere un sapere arcano e segreto, senza aver intrapreso una opportuna preparazione per accoglierlo.
.