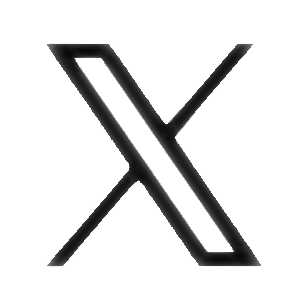di Marco Palombi
Immagina una barca sul lago di Tiberiade, notte nera come pece, solo le stelle a far da testimoni.
Gesù – non il Cristo dipinto nei Vangeli, no, uno più alto, più luminoso, quasi traslucido – siede a prua. Ha la veste che non è veste, è luce viva che gli ondeggia addosso come acqua. I discepoli
sono lì, stretti in cerchio, il fiato che sa di paura e meraviglia. Lui alza la mano, e il mondo... si ferma. Il vento tace. Le onde si placano. Poi inizia.
Parla di Pistis Sophia.
Non è una donna, non esattamente. È un Aeon, una scintilla divina nata dal Pensiero Invisibile. Viveva lassù, nel Pleroma, dove tutto è ordine e canto. Ma Yaldabaoth – quel falso dio con testa
di leone e corpo di serpente – la inganna. Le dice: Guarda giù, nel caos. È lì la tua vera bellezza. E lei, innocente, si sporge e precipita. Veloce come una lacrima su una guancia fredda. Cade tra i cieli intermedi, tra gli arconti che ridono. Il suo manto di luce si lacera, il suo sigillo si spezza. E allora grida, non un grido umano, ma un suono che spacca l'anima: “Mi hanno tolto la mia veste, mi hanno strappato il mio potere. Padre, salvami dal leone.”
E Gesù, lì sulla barca, sente quell'eco. È lui il Salvatore sceso proprio per quello.
Si alza. Il lago trema.
E inizia a spiegare. Tredici cieli da attraversare. Trentadue potenze da ingannare. Ognuna con un nome impronunciabile, un sigillo da spezzare.
Maria Maddalena lo guarda negli occhi. Tu lo sai, dice. Sai cosa c'è dietro il velo. E lui, piano: Sì,
Maria. Dietro il velo c'è il Silenzio. Ma prima, c'è il dolore. Ascoltali, i discepoli: Pietro stringe i pugni, Giovanni ha le lacrime, Tommaso scuote la testa incredulo.
E Gesù continua, voce che sembra venire da dentro il petto di chi ascolta: Ogni anima è Pistis.
Ogni anima cade; ogni anima deve risalire. Con la fede, con la Sapienza, con il canto.
Il primo cielo non è un posto lontano.
È il tuo stesso respiro quando ti svegli spaventato, senza sapere perché.
Lì ti aspetta Iao, il leone alato. Non ha ali vere, no. Ha membrane di luce che si strappano piano mentre avanza. Il suolo sotto di lui è vetro fuso, ancora caldo, che riflette te – ma non come sei,
come potresti essere se smettessi di credere alle bugie.
2
Ti guarda dritto negli occhi. Non parla subito. Ti lascia avvertire il peso.
Poi, piano, quasi come un ronzio che ti vibra nelle ossa: “Mostrami il tuo nome. Non quello con cui ti chiamano gli altri. Quello che porti nel cuore.”
E tu, se non lo sai, resti lì. Il tempo si dilata. Un secondo diventa un'ora. Diventi polvere che si posa sul vetro. Ma se, tra quel silenzio che ti rompe, ricordi - non dici, ricordi, come quando da
piccolo sapevi di essere salvo solo perché tua nonna ti stringeva, o quando, prima di dormire, sentivi il mondo respirare con te – trovi in quel ricordo il nome. Lo pronunci. Barbelo.
Barbelo non è una parola, è un respiro. Significa... ciò che per primo che emana dal Padre. Non Dio, ma non quello che con quel nome chiamano gli uomini. Il Padre Invisibile, quello che non è.
Barbelo è la sua idea di sé stesso fatta luce. È la Madre, ma non quella che ti ha partorito, ma quella che ha partorito te, e tutto.
In qualche testo antico, la chiamano la Vergine, la Saggezza, la Prima Immagine. È colei che sta prima di ogni cosa, ma non prima nel tempo. Prima nell'essere.
Pensa a quando guardi il cielo e senti... pace. Senza ragione. Ecco. Barbelo è quella pace. Non la tocchi, ma la hai. Quando dici quel nome nel primo cielo, non stai invocando una dea. Stai
ricordando di essere nato da lei. Di non essere mai stato solo. Di non cadere davvero. Mai.
Non lo urli, quel nome, lo sussurri. E il leone si ferma, le ali si richiudono. Il vetro si raffredda. E ti fa largo. Non dice grazie, non dice niente. Ma i suoi occhi, per un attimo, sembrano umani.
E tu passi. Portandoti dietro il calore. E quel calore? È tuo. È sempre stato tuo.
Il secondo cielo non è più semplice.
È dove Adamo aspetta. Ma non l'Adamo dell’Eden: quello è un'altra bugia.
Qui è Adamo il Guardiano. Alto come un ricordo, magro come un filo d'erba morta. Pelle di pergamena, occhi di luna vuota. Indossa un manto fatto di nomi: tutti i nomi che hai avuto.
Bambino. Figlio. Fratello. Fallito. Colpevole. Ogni volta che te ne dai uno nuovo, lui lo prende e lo cuce sul suo petto.
Cammina piano, scalzo, sul vetro nero. Non parla, ti guarda. E tu senti i tuoi nomi pesare. Ti chiede, senza aprire bocca: “Chi sei oggi?” E se gli rispondi con uno di quei nomi vecchi – sono
Giovanni, sono Maria, sono chi ho perso – lui annuisce, e il manto si stringe. Ti avvolge. Ti soffoca.
Diventi un'ombra cucita alla sua schiena.
Ma Pistis – lei, ormai, sa. Non risponde. Si toglie il suo nome. Non dice niente, lo lascia cadere via.
Adamo vede ciò. Esita un attimo, e poi il manto si allenta. Non si può cucire il silenzio: il silenzio non ha bordi. E allora, piano, con voce di ghiaia Adamo dice: “Passa. Non sei più niente.” Ma il
niente è già tutto, e il secondo cielo si apre.
3
Il terzo cielo è umido.
Sembra una cantina dimenticata da secoli. Qui regna Adonaios, testa di bue, con corna ricurve come domande non fatte.
Il corpo è tutto rame ossidato, che stride quando si muove. L'aria odora di ruggine e preghiere stantie. Non ti chiede niente. Ti lega con catene di parole che hai detto e non hai detto. “Mamma,
perché non torni?” “Ti odio.” “Ti voglio.” “Non lasciarmi”. Ogni tua frase è un anello della catena, e pesa come un masso.
Adonaios non ride. Non parla. Ti guarda con quegli occhi tondi da bue, e tu senti che la catena si stringe intorno alle costole. Se cerchi di strapparla, sanguini nomi. Se resti fermo, diventi una statua di rame.
Ma Pistis si ferma. Chiude gli occhi e ricorda. Non le parole: il silenzio dietro di esse. Quello che c'era prima che parlassi. Prima che ti chiamassero. Prima che ti spezzassero.
E in quel silenzio, la catena arrugginisce. Non si spezza con la forza, si sfalda. Adonaios lo vede.
Le corna si chinano. Il rame geme. E tu passi. Le catene restano lì, a dondolare da sole. Vuote. Ma non sei libero. Sei... vuoto.
In questo cielo il vuoto non è silenzio, è assenza. Adamo, nel secondo cielo, ti aveva tolto il nome, ma senza strappartelo, facendotelo dimenticare, estinguendolo– come se non fosse mai esistito. E tu, per un attimo, non sei più.
In questo terzo cielo, senza le parole, tu non hai più peso, non hai più storia. Ti senti come un foglio bianco, ma non nuovo. Bianco e consumato, perché tutto ciò che eri è stato letto, usato,
cancellato. E lì, nel vuoto, Adamo ti chiede: “Vuoi un nome nuovo? Vuoi tornare a essere qualcuno?” Ma se lo fai, ti ricuce addosso un altro nome, un'altra colpa, un altro velo.
Il vuoto, vedi, è una trappola, ma anche un invito.
Pistis non ha accettato il nome nuovo: accetta invece il vuoto. E nel vuoto ha sentito: “Non sono il nome. Non sono la storia. Sono ciò che resta quando tutto è strappato.”
E quando hai capito quello, Adamo non ha più niente da cucire. Non può inchiodarti. Perché non c'è più un te da inchiodare. E il vuoto diventa spazio. Spazio per passare, per salire
E il vuoto è il primo passo verso l’alto.
Il quarto cielo è dolce. Troppo.
Fa pensare alla casa di nonna, a panni stesi, ad una torta che cuoce. Ma è ingannevole.
Eloaios è lì, seduto su una sedia di nuvole. È piccolo, grassoccio, con un grembiule a fiori. Occhi azzurri, innocenti. Ti offre una tazza. Dice: “bevi. È latte caldo con miele”. E tu, dopo tutto quel
4
freddo ed il peso della catena, allunghi la mano. Ma dentro non c'è latte. C'è oblio. Bevi e dimentichi non solo il dolore: dimentichi pure il perché stavi salendo.
Dimentichi Pistis, dimentichi la barca, dimentichi Gesù.
Diventi un sorriso beato, seduto a gambe incrociate. Un bambino felice. Un cane che scodinzola.
Niente più lacrime. Niente più domande. Niente più volo.
Pistis non beve. Lo guarda. Lui sorride. Lei dice: “hai ragione, è dolce. Ma non mi appartiene”.
E si volta. Il quarto cielo non la ferma, perché non c'è niente da fermare. Lei non ha più bisogno di dolcezza. Ha bisogno di verità. E la verità non sa di zucchero. Sa di sale, sa di lacrima. E allora
Eloaios sospira. Il grembiule si affloscia. E lei passa. La tazza resta lì, fumante. Ma nessuno più la berrà.
Il quinto cielo è gelo puro.
Astaphaios sta al centro, nudo, con la pelle di ghiaccio. Ogni suo respiro esce come nebbia bianca e congela l'aria a due passi da lui. Non ha occhi. Ha solo due buchi vuoti da cui soffia vento boreale.
Non ti chiede nulla. Ti circonda. Il freddo ti entra nelle ossa, ti fa tremare i pensieri. Le lacrime ti si gelano prima di cadere. Se non fai niente, diventi statua di brina. Bella, silenziosa, perfetta. Ma
morta.
Pistis si ferma. Non trema. Inspira. Non col fiato che conosci tu, ma col fiato che resta quando non hai più paura del freddo.
Inspira e poi canta. Non parole. Un inno antico, senza testo. Sale dal petto come una fiamma. La voce è esile, ma spacca il ghiaccio.
Astaphaios gira la testa. Il vento rallenta. Lei continua.
Ogni nota è un ricordo: la barca, la luce di Gesù, il lago che non gelava mai.
E il ghiaccio si scioglie. Goccia a goccia. Astaphaios non si muove. Resta lì, nudo, con i buchi che ora fumano. Non la ferma, non può. Il freddo non entra più dove c'è canto.
E il canto non ha bisogno di parole. Ha bisogno di memoria. Di fuoco interno.
E lei passa. Dietro di lei, il quinto cielo resta lucido. Ma non più intoccabile. Una crepa, sottile, verticale. Come una lacrima congelata che ha smesso di esserlo.
Il sesto cielo è buio pesto.
5
Ailoaios non ha corpo. Ha solo un'ombra: la tua. Si muove come te, ma un passo avanti. Ti fa credere che sia lì per proteggerti. Ti dice: “cammina con me, così non ti perdi.” Ma ogni passo che
fai, lui allunga la sua ombra e la tua si accorcia, fino a sparire.
E quando non hai più ombra, lui ti dice: “ora sei mio.” Non puoi più tornare. Sei solo eco.
Pistis lo vede. Non parla. Non combatte. Fissa la sua ombra. La guarda diventare sempre più lunga, sempre più dell’altro. Poi si ferma, e, sempre tacendo, si lascia avvolgere. L'ombra la inghiotte.
Tutto è nero e silenzio.
Ma dal nero scaturisce un sussurro: “io non sono la mia ombra. Sono la luce che la proietta.” E l'ombra si ritrae. Si piega come un cane bastonato.
Ailoaios non ha voce per rispondere. La sua, di ombra, diventa piccola piccola. Quasi un puntino.
E Pistis passa. Non perché abbia vinto, ma perché ha capito: l'ombra non può esistere senza luce.
E la luce non ha bisogno di ombra.
Ma se l’ombra ti chiama, tu puoi farla tornare della luce. E allora il sesto cielo diventa solo un posto dove cammina la luce. Senza fretta, senza paura.
Il settimo cielo è ferro. Puro, pesante, opaco, senza riflesso.
Oraios è un colosso di lame. Ogni sua giuntura stride, ogni passo è un chiodo nel silenzio. Ha braccia come incudini, occhi come carboni spenti. Non ti guarda. Ti afferra, ti incatena. Ma non
con catene normali: sono i tuoi ricordi pesanti. Il bacio che non hai dato, la mano che non hai stretto, la porta che hai chiuso sbattendo. Ogni anello è un rimpianto.
E tu, lì, appeso, senti il ferro stringersi. Il sangue raggela nelle vene, il cuore rallenta. Se ti aggrappi, resta tutto così, per sempre.
Pistis non si aggrappa. Chiude gli occhi. E invece di pensare ai rimpianti, pensa a ciò che il ferro non può trattenere. Pensa al calore, al respiro di Gesù sulla barca, alla voce che le diceva: “tu non
sei la tua catena. Sei il fuoco che la forgia.” E quel fuoco, lo sente, lo lascia uscire. Non brucia il ferro: lo scioglie. Goccia a goccia, come pioggia calda su una lastra di marmo.
Oraios resta lì, con le braccia vuote, gli occhi ancora spenti. Non protesta, il ferro non protesta: si piega. E Pistis scende. Non scivola. Cammina tra i rivoli di metallo fuso.
Il settimo cielo resta aperto. Come una forgia dopo che il mastro se n'è andato. Calda. Silenziosa.
Pronta per un'altra forma.
L'ottavo cielo non ha forma.
6
Kaiomai è un orologio senza lancette. Un pendolo che oscilla al contrario.
Quando entri, il tempo ti guarda. Non passa, ti aggira. Un secondo indietro, un'ora avanti.
Ti perdi. Ti vedi da vecchio, da bambino, da morto. Ti chiede: “Vale la pena salire?” Ti mostra tua madre che piange perché non hai salutato. Ti mostra te stesso che inciampi sul tredicesimo gradino
e cadi indietro. Ti mostra un letto vuoto, una lettera che non arriva. E tu, se rispondi sì, continui.
Ma ogni sì costa un ricordo. Uno vivo, caldo. Finché resti nudo di vita.
Pistis non risponde. Guarda Kaiomai. Gli chiede: “Tu hai paura del tempo?” Lui tace. Il pendolo rallenta. Lei dice: “Allora lo prendo io”. E cammina. Non avanti, non indietro.
Cammina nel ticchettio. Come se fosse la risacca. E il tempo si piega. Diventa un nastro che le si avvolge al polso. Non la ferma, non può. Il tempo non può fermare chi non ha fretta.
E l'ottavo cielo resta lì. Un orologio con le lancette ferme. Ma con una tacca, una sola, come una cicatrice. Come un sì che non ha detto no.
Il nono cielo è un tamburo.
Yablas batte e il suono ti entra nel sangue. Boom. Bum. Boom. Bum. È ritmico, ipnotico. Come un cuore che non è tuo. Come una danza che non hai scelto. Se ti lasci prendere, muovi i piedi.
Balli, sudi, ti stanchi. E poi cadi. Non muori; peggio: continui a ballare, con la lingua di fuori e gli occhi persi.
Finché di te non resta che carne che trema al ritmo di un dio finto.
Pistis sente il colpo di tamburo e non muove un dito. Smette di sentire il battito. Non con le orecchie, con l'anima. Ascolta il silenzio: quello che resta quando il tamburo non batte. Il silenzio
tra due colpi. Lì dentro c'è spazio, c'è aria, c'è un respiro.
E quando quel respiro è più forte del suono, Yablas perde. Il tamburo rallenta. Lei non balla. Non canta. Respira. E il nono cielo si spegne. Resta il silenzio. Ma non è vuoto: è pieno di un altro
ritmo. Più lento, più vero. Il tuo.
Il decimo cielo è dove il vero mostro ride.
Yaldabaoth. Testa di leone, criniera di fiamme azzurre, corpo un serpente che si arrotola su se stesso. Ti guarda dall'alto. Gli occhi brillano di un rosso che non esiste. Dice: “Io ti ho fatto. Io
sono il tuo dio.” E tu credi. O almeno, ci credi per un po’.
Finché non alzi lo sguardo.
Pistis lo fa. Non trema. Non prega. Pronuncia il suo nome: Saklas. Il folle, il cieco, colui che si crede padre ma è solo un aborto del Pleroma.
7
Yaldabaoth ruggisce. Ma non è un ruggito forte, è spezzato. Come se si stesse accorgendo di essere una barzelletta.
Il serpente si tende, le squame si increspano. Ma non la tocca. Non può.
Perché quando lei dice Saklas, non lo insulta, lo rivela a sé stesso.
E quando un dio falso scopre di essere falso, non ha più armi.
Il decimo cielo si contrae. Le fiamme diventano brace. Il leone abbassa la testa. Non per sottomissione, ma per vergogna.
E Pistis passa. Non perché sia più forte, ma perché ha visto: dietro la maschera c'è solo polvere.
E la polvere non blocca la luce.
L'undicesimo cielo è un giardino.
Non di fiori, ma di specchi. Armozeus è lì, seduto su una panchina d'argento. Non ha volto: indossa il tuo. Ti guarda e ti dice: “Siediti. Raccontami il tuo ultimo pensiero. Non quello che pensi
ora. Quello che hai avuto prima di entrare qui. Prima di cadere. Prima di scegliere di risalire.” E tu glielo dici.
Pistis non si siede. Lo guarda e dice: “L'ultimo pensiero è sempre lo stesso. Padre. O Madre. O luce. O niente. E niente è tutto.”
Armozeus sorride. Ti porge la tua ombra. E Pistis prende l'ombra. Non la guarda. La abbraccia.
E il suo ultimo pensiero esce dalla bocca come fumo: “Non ho paura.” E Armozeus si dissolve.
Non muore. Si riunisce. Con lei, con te. Il giardino resta, ma gli specchi ora riflettono solo luce.
Niente più te. Niente più lui. Solo luce.
E un sentiero. Che sale, piano, verso il silenzio.
Il dodicesimo cielo è vuoto.
Sauoias non c'è. O forse sì, ma non lo vedi.
È la tua ombra, quella che hai lasciato nel sesto cielo. È tornata qui, ti aspetta, con le braccia spalancate. Dice: “Dai, resta. Sono io. Sono te. Sono tutto ciò che hai perso. La mamma. Il tuo
cane. Il tuo primo bacio. La barca. La luce. Il silenzio.” E se la abbracci, ti stringe forte. Finché non resta di te più niente, finché non sei solo un sospiro.
8
Pistis la guarda. Non dice niente. Si siede per terra, la guarda camminare.
E poi le dice: “Tu non mi manchi. Tu non mi servi. Io non ti ho persa: tu sei sempre stata qui.”
E l'ombra esita, trema. Poi si sdraia come un cane stanco. Come se per la prima volta dormisse. E svanisce.
E Pistis si alza. Il dodicesimo cielo resta. Ma ora è una stanza con un letto, con un lenzuolo.
E qualcuno – forse – può venirci a dormire. Quando vorrà.
Il tredicesimo cielo non esiste.
O meglio, non c'è più. Quando Pistis ci arriva, trova solo silenzio.
Non buio, non luce: silenzio.
Non c'è vento, non c'è eco. Non c'è più nemmeno la barca. Solo un lago fermo, liscio. Come se
l'acqua non avesse mai toccato il cielo.
E lì, in piedi sull'acqua, c'è Gesù. Non parla. Non sorride. Non tende la mano. Guarda Pistis come se l'avesse aspettata da sempre.
E lei non piange, non si inginocchia. Si toglie l'ultimo velo. Quello che non aveva nome. E lo lascia cadere.
Non fa rumore. Non va da nessuna parte. Scompare.
E resta solo il Silenzio vero. Non quell’attimo tra due parole. Quello prima delle parole. Prima del cielo. Prima di Pistis. Prima di tutto.
E lì, dentro il Silenzio, lei non è più Pistis. Non è più Sophia. Non è più caduta. Non è più salita.
È. Solo è.
E Gesù sussurra – ma non con parole – : “Benvenuta a casa.”
E il lago si di Tiberiade si apre. Non verso il basso, non verso l’alto. Oltre.
E tutto finisce senza morire. Diventa.
E la barca resta lì, vuota ma non abbandonata.
I discepoli tornano al mattino, con gli occhi ancora pieni di meraviglia. Non chiedono dove sia
Gesù: lo sanno. Non chiedono dov'è Pistis: lo sanno.
9
Pietro tocca l'acqua: calda. Giovanni guarda il cielo limpido. Tommaso ride. Una risata bassa, da petto.
E poi, piano, la barca si muove da sola. Non c'è remo, non c'è vento. Si muove perché deve.
E loro, a bordo, non hanno più domande. Solo una certezza, che stanno tornando. Non indietro, ma oltre. Nel mondo, ma cambiati.
Camminano per i campi, per le città, per i mercati, e ogni tanto, senza volerlo, dicono una parola.
Barbelo. Saklas. Silenzio.
E qualcuno li ascolta, qualcuno trema, qualcuno ricorda. E poi passa.
E la Pistis Sophia è un sussurro. Che trovi quando meno te lo aspetti, quando sei solo, quando fa freddo, quando pensi di essere caduto...
E in quel sussurro, senti: non sei caduto. Hai solo chiuso gli occhi.
Aprili!