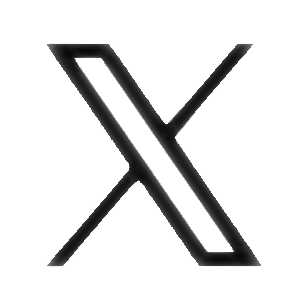di Aldo La Fata
Gaston Bouthoul e la sociologia della politica come scienza del conflitto
Una lettura metapolitica
La recente pubblicazione, per le Edizioni Il Foglio, del volume Sociologia della politica di Gaston Bouthoul, a cura di Carlo Gambescia e Jerónimo Molina, restituisce al pubblico italiano un testo di eccezionale rilievo nella genealogia della scienza sociale novecentesca. L’opera, originariamente apparsa in Francia nel 1965 e oggi riproposta in edizione arricchita da una bibliografia ragionata e da un apparato iconografico, consente di accostarsi a un autore che, pur rimasto marginale nel canone accademico, occupa una posizione centrale nella storia del pensiero politico e sociale.
Nato a Monastir (Tunisi) nel 1896 e morto a Parigi nel 1980, Bouthoul non fu un professore di carriera né un accademico di sistema, ma un ricercatore libero, refrattario tanto ai conformismi universitari quanto alla pretesa “neutralità assiologica” della sociologia positivista. Sociologo, demografo e filosofo della storia, egli si colloca all’incrocio di discipline differenti, nel punto in cui la riflessione scientifica incontra l’interpretazione antropologica e culturale del conflitto. È noto soprattutto come fondatore della polemologia, ossia di quella scienza che assume la guerra non come accidente patologico della civiltà, ma come fenomeno ricorrente e strutturale della vita collettiva. L’obiettivo è individuare le costanti biologiche, demografiche, economiche, psicologiche e politiche che rendono il conflitto una realtà regolare, non un’anomalia episodica, bensì una funzione interna all’organizzazione sociale.
La curatela di Gambescia e Molina, sobria nell’impianto ma intellettualmente densa, restituisce a Bouthoul la sua autentica collocazione nel panorama del pensiero politico del secondo dopoguerra. I curatori sottolineano come la sua sociologia rappresenti l’esatto opposto del “presentismo” oggi dominante nella disciplina – quella visione che appiattisce l’orizzonte storico in un eterno “presente” –, ricordando al tempo stesso che Bouthoul fu stimato da Julien Freund, disprezzato da Alfred Sauvy e, più in generale, frettolosamente liquidato dagli specialisti come un dilettante. I curatori osservano invece acutamente come il suo pensiero “si collochi idealmente tra i sociologi ‘liberali’ quali Tocqueville, Spencer, Weber e Pareto” (p. 8), delineando così una genealogia intellettuale che, pur estranea agli schemi accademici, lo lega ai grandi analisti della società moderna.
Il volume si articola in tre grandi sezioni - Le istituzioni, Gli uomini, Le finalità e le forme dell’azione politica - che tracciano una vera e propria morfologia del potere, dalle strutture e mentalità politiche, alle gerarchie biologiche, economiche e sacrali, fino alle motivazioni profonde dell’azione collettiva. In tale quadro, libertà e violenza non si contrappongono, ma rappresentano i due poli dialettici di un medesimo principio antropologico, ovvero la lotta come fondamento della vita sociale.
Poiché non è possibile affrontare qui la complessità di tutte le questioni sollevate dal volume né citare i tanti passaggi folgoranti alternati da citazioni di autorità famigliari alla cultura tradizionale (da S. Agostino a Ernst Jünger passando per Lao Tse), ci si limiterà all’esame del nucleo teorico essenziale della polemologia bouthouliana, individuabile in due assi complementari: la guerra come fatto sociale regolare e ricorrente e la guerra come valvola demografica.
Secondo Bouthoul, il fenomeno bellico si ripresenta con periodicità costante nella storia dei popoli e non può essere ricondotto né alla follia dei governanti, né a errori diplomatici o a deviazioni morali individuali. La guerra obbedisce, piuttosto, a cause collettive e strutturali, a tensioni di ordine biologico, economico e demografico che, una volta superata una soglia di saturazione, si traducono in esplosione di violenza. In tal senso, Bouthoul ipotizza un nesso diretto tra sovrappopolazione e conflittualità. La guerra agirebbe come un meccanismo - in gran parte inconscio - di regolazione della pressione demografica e delle tensioni socio-economiche conseguenti e quindi apparirebbe, paradossalemnte, come uno squilibrio necessario, come un evento tragico, ma funzionale al ristabilimento di un equilibrio compromesso dall’eccesso di crescita.
A mio modo di vedere, il concetto di “regolarità” formulato da Bouthoul potrebbe essere letto, in chiave comparativa, come la trasposizione secolarizzata della nozione arcaica dei cicli cosmici propri alle dottrine tradizionali e in particolare alle dottrine indù. Là dove il sociologo constata la ricorrenza storica della guerra, le cosmologie tradizionali vedono nel conflitto il segno della degenerazione di un ciclo, l’effetto di una frattura tra l’ordine celeste e quello terreno. La ripetitività del fenomeno, per Bouthoul, è indice di causalità sociale mentre per la Tradizione, è sintomo escatologico, un segnale che accompagna la dissoluzione di un’epoca.
Nella visione tradizionale, l’ultima fase del ciclo - il Kali-Yuga in India, o il tempo dell’Anticristo nel cristianesimo - è contrassegnata da un’intensificazione del conflitto, dalla massima visibilità della violenza e dalla perdita della dimensione sacrale della guerra. In modo sorprendentemente analogo, Bouthoul individua nel boom demografico del XX secolo - da un miliardo di abitanti nel 1900 ai quattro miliardi da lui censiti negli anni Sessanta, fino agli otto miliardi odierni - la causa principale dei due conflitti mondiali. Si tratta, per lui, di un effetto quantitativo, di una sorta di hybris numerica che destabilizza il corpo sociale.
A un livello più profondo, René Guénon, nel Regno della quantità e i segni dei tempi (1945), giunge a una conclusione simile ma fondata su presupposti metafisici. Per il metafisico francese, la guerra moderna - generata dalla quantificazione integrale dell’esistenza, dalla meccanizzazione e dalla massificazione della vita - rappresenta, in opposizione alla lettura puramente statistica di Bouthoul, la manifestazione esteriore di una disintegrazione interiore dell’uomo moderno, di cui egli offre la diagnosi metafisica.
Anche Silvano Panunzio svilupperà un discorso analogo a quello di René Guénon, ma stavolta nel solco del pensiero cristiano tradizionale. Il cattolico ferrarese in Metapolitica – La Roma Eterna e la Nuova Gerusalemme (1976) vedrà la storia come un dramma sacro-politico in cui la civitas dei (metapolitica), la civitas terrena (politica) e la civitas diaboli (criptopolitica) si fronteggiano. La guerra è da questo punto di vista una sorta di rivelatore escatologico e ogni conflitto mondiale è una “apocalisse ridotta”, ovvero una prefigurazione del giudizio finale in cui le potenze celesti e quelle inferiche che guidano la storia sotto parvenze ideologiche o economiche o tecniche si scontrano. Panunzio conserva la nozione di bellum iustum agostiniano-tomista, ma osserva che nel mondo moderno la guerra tende a perdere ogni riferimento a un ordine trascendente, dissolvendosi nel puro conflitto tecnico-ideologico.
Nessun evento dunque, neppure quello apparentemente più profano, può essere escluso dalla dinamica redentiva.
Da questo punto di vista, la sociologia della guerra o polemologia di Bouthoul si rivela descrittiva ma non discriminante. Questo il suo limite.
Ma nonostante la distanza dei presupposti, Bouthoul e i pensatori tradizionali come Guénon e Panunzio convergono su alcuni punti essenziali. Anzitutto, la negazione dell’accidentalità della guerra. Per entrambi infatti, il conflitto non è un incidente della storia ma ha una sua legge interna e cioè è un fenomeno strutturale, inscritto nel ritmo stesso del divenire; per entrambi l’idea progressista di una storia lineare orientata verso un indefinito “meglio” è da escludere con il ché si va a smentire ogni teleologia ottimistica; per entrambi, infine, occorre diffidare del pacifismo ideologico,
per Bouthoul, perché la pace non può nascere da un’esortazione morale, ma solo da un equilibrio organico di forze contrapposte e per i pensatori della Tradizione, perché il pacifismo tradisce una visione puramente biologica dell’esistenza che non solo non comprende l’importanza del sacrificio come elemento sacro che trascende la mera conservazione della vita, ma che vorrebbe addirittura cancellarlo persino esistenzialmente.
Si potrebbe a questo punto affermare che la polemologia di Bouthoul fornisce la base empirica per una possibile polemologia metapolitica. Laddove la polemologia registra i sintomi della malattia, la Tradizione ne offre la diagnosi metafisica ed escatologica; laddove la sociologia del conflitto descrive il fenomeno visibile, la metafisica della guerra ne svela le cause invisibili.
Tuttavia, non possiamo nasconderci il fatto che l’apparente neutralità di Bouthoul che riduce la guerra a mero fenomeno demografico implica un sotteso biologismo sociale. In tal senso, ad avviso di chi scrive, Bouthoul partecipa suo malgrado a quel processo di immanentizzazione del sapere moderno, in cui l’analisi empirica avanza, ma a prezzo della perdita delle dimensioni superiori dell’intelligenza.
Un progresso nella sintomatologia, ma un regresso nella comprensione del dramma cosmico che attraversa la storia umana. Solo una lettura integrata capace di assumere la polemologia bouthouliana come archivio dei fenomeni e la metafisica tradizionale come criterio di verità, potrebbe costituire un terreno fecondo di indagine e, se mai fosse accolta nell’ambito della prassi politica, persino un argine contro molte delle calamità storiche che affliggono l’umanità. Ma si tratta, verosimilmente, di una pia illusione, poiché proprio le religioni tradizionali, che dovrebbero alimentare e amplificare tale visione, appaiono oggi assorbite quasi interamente dallo sforzo di sopravvivere in un mondo che le respinge, più che dal compito di illuminarlo.